
A colloquio con Federico Tocci sugli sprazzi di talento della recitazione
Scritto da Massimiliano Serriello il . Pubblicato in Cinema, Musica e Teatro.
IL CIGLIO ASCIUTTO DI UN ATTORE DALLA MOLE MASSICCIA E DALLO SGUARDO CERBIATTESCO
Una conversazione con Massimiliano Serriello
L’intenso contrasto tra la stazza massiccia e l’introversione degli indugi permette a Federico Tocci di andare oltre il limite dei ruoli fissi destinati ai meri caratteristi. All’attore romano, incline, per ragioni di sangue e di suolo, all’acume mordace del vernacolo capitolino, che scorge nello storico disincanto una sorta di cinismo bonario, la densità testuale, conforme ai ruoli più impegnativi, piace. Eccome. È nelle sue corde, d’altronde. Insieme al dono dell’autoironia e alla capacità di trarre linfa dagli insegnamenti appresi sia nella cosiddetta università della strada sia nell’opportuno e inesausto studio della psicotecnica. Senza mai dare per scontate le incombenze di chi deve sudare sette camicie con la regìa per riuscire ad annettere gli slanci imprevisti ma proficui della poiesis, cara ai filosofi, all’indispensabile praxis costituita dalle componenti tecniche.
L’esordio dietro l’ardua macchina da presa del collega e amico Marco Bocci (nella foto), che lo ha ribattezzato teneramente zio Thor, costituisce la prova dell’umiltà necessaria a favorire, alla superbia delle scene lusinghiere e all’esca del numero di pose fine a se stesse, la sostanza dell’indicativo lavoro di sottrazione. 
L’opera prima, A Tor Bella Monaca non piove mai, lo trova prontissimo nel ruolo di un commissario deciso a non buttare al macero mesi d’appostamento, per rendere pan per focaccia ai delinquenti che riciclano denaro sporco, nonché ad accudire un collega vittima dei disvalori imperanti nel territorio amico attanagliato dagli empi nemici.
Il relativo senso di appartenenza, restio a ricorrere ad alcun tipo di gigionesco soprassalto esibizionistico, non premia solo ed esclusivamente la professionalità di mettersi a disposizione della scrittura per immagini: dimostra, altresì, come un’empatica mimica facciale comunichi tanto quanto le forme geometriche dell’inquadratura e i match-cut visivi intenti ad accrescere l’imprinting di dettagli rivelatori ed ellissi temporali.
L’amicizia che lo lega a Tony Sperandeo, con cui ha condiviso il set della nota serie televisiva La squadra, non c’entra nulla con le reboanti ostentazioni di stima dei fan. La fragranza dell’affetto sincero, frammista ai palpiti dell’ammirazione per il ritratto acuto ed epidermico conferito in qualsivoglia ruolo, ivi compreso l’inquieto sovrintendente Salvatore Sciacca, balza agli occhi.
L’ispettore Walter Battiston è un po’ il fiore all’occhiello di Federico Tocci. L’accento veneto, la mole robusta, lo sguardo cerbiattesco, la punta di spina del dolore per le frecce di Cupido scoccate a discapito della fortuna, che gli chiede spesso il conto, impreziosiscono gli sprazzi di talento impiegati per fungere da valido pungolo. Allo scopo, in prima battuta, di prendere confidenza con un’inflessione dialettale assai diversa da quella dei cittadini dell’Urbe. Al fine, in seguito, di dare l’acqua della vita all’aspetto spirituale, interiore, dell’onesto sbirro messo a capo delle Volanti. Pronto a cedere di nuovo il posto. Con la purezza di cuore garantita dagli sguardi introversi ed eloquenti.

Al gigionismo del fuoriclasse Sperandeo, che riesce a diventare spietato e compassionevole, sbeffeggiatore e comprensivo, scattoso e mesto, soverchiatore ed empatico, sulla scorta dell’eterogeneo sviluppo dell’intreccio, congiunto all’estrinseca vena teatrale, Federico replica con la farina del suo sacco. La sottorecitazione lo esorta, infatti, ad anteporre i semitoni agli accenti. Anche se pure quelli gli riescono bene.
È, comunque, il trasporto intimo, estraneo all’infruttifero diktat imposto dalle circostanze esteriori determinate dal plot, a preferire i segnali discorsivi, gli accenni, le parole non dette a garantire la fondatezza ad alcune performance altrimenti inclini ai virtuosismi vezzosi. Inutili, sia in prassi sia in spirito, allo studio della vicenda da raccontare ed esibire in tutte le sfaccettature del caso. Frutto dell’ingegno dell’autore.
In Suburra – La serie, a dispetto delle accuse lanciate contro l’inattendibilità di alcuni contesti, che permettono allo zingaro soprannominato Spadino di entrare e uscire dalle case dei cardinali in Vaticano, ad agire senza azione provvede l’insita antiretorica.
Il boss di Ostia, Tullio Adami, ricava notevole spessore dalla partitura sotterranea percorsa da Tocci per scolpirne le ubbie e la rabbia belluina. Contraddetta dall’incedere di alcune sensibili occhiate diametralmente opposte ai battutissimi sentieri conformi alla cifra dell’odio scellerato.
La cifra dell’amore, invece, per il figlio ribelle, incarnato con indubbia abilità da Alessandro Borghi (nella foto con Federico in un lampo cruciale), rende molto più interessante il succedersi degli eventi. 
Il mancato punto d’incontro tra i due, divisi dai temperamenti bellicosi, negati all’adeguatezza catartica di una sana chiacchierata, rimane nella memoria. Quando l’impetuoso rampollo sfugge alla morte, per il rotto della cuffia, nell’aria attorno alla roccaforte vicino al mare preme un’arida ed emblematica uggia. La morbosa suscettibilità di entrambi sembra cedere il passo ad attimi fuggenti intessuti di premura virile.
In Sulla mia pelle di Alessio Cremonini il grande schermo lo vede di nuovo accanto ad Alessandro Borghi (nella foto le scene topiche), premiato con l’ambìto David di Donatello per la performance fornita nelle vesti di Stefano Cucchi. Sono sufficienti pochi secondi a Federico, che impersona un poliziotto preoccupato in apparenza unicamente di lavarsi le mani tipo Ponzio Pilato dinanzi ai segni d’atroce percossa rilevati sul corpo smagrito all’inverosimile del ragazzo: si ha fortissimamente l’impressione che l’incolpevole guardia dica una cosa, dettata dall’algido sarcasmo, e ne pensi un’altra. Agli antipodi. Sull’onda di un’indicibile indulgenza. La spia alla comprensione celata dall’ovvio distacco di rito. 
Ai modi asciutti, che non gli impediscono di esporre i recessi più arcani dell’inconscio, custoditi con l’ausilio del sarcasmo gergale, e traditi dagli occhi cerulei, promossi a specchio dell’anima intenta a scoprire diverse zone d’ombra, illuminate dall’inopinata docilità, seguono le argomentazioni sagaci. Snocciolate senza l’improntitudine degli intellettuali estranei alla saggezza popolana. I fulgidi globi oculari, ridotti in certe circostanze a fessure iniettate di sangue, quando le sagome scure del Rischio e della Minaccia prendono piede attraverso il rapporto della finzione cinematografica col reale, lontano da qualunque, inutile forma artificiosa, tornano ad accendersi fuori del set.
Una testimonianza di pienezza compartecipe. Allergica agli imperativi dei calcoli professionali. Alla prospettiva, nemmeno troppo remota, di aggiudicarsi un David di Donatello, come attore non protagonista per l’insolito commissario di A Tor Bella Monaca non piove mai, con l’antidoto al braccio violento della legge, non ci pensa. Gli basta salvaguardarsi dalle crisi occupazionali che affliggono tutti gli attori esclusi dall’effigie dorata attribuita dai seguaci dell’inane divismo.
Recitare, per Federico Tocci, è un mestiere irrinunciabile. Che ama per motivi che non hanno nulla a che vedere con la brama di procacciarsi chissà quale quotazione sul mercato né con il freddo raziocinio. Abituato ad affidare alla fotogenia il compito di sopperire all’impasse di una recitazione meccanica. Nel suo caso il connubio delle forme somatiche del volto con la gamma luministica, assicurata dagli alacri direttori della fotografia, possiede la polpa dell’affetto. Tramutato in conoscenza. Per dare il benservito ad arzigogoli ed elucubrazioni varie. Il cuore, sintomo di sensibilità e d’audacia perenne, è tutta un’altra camminata. L’entusiasmo creativo e i piedi per terra non si annullano l’un gli altri. Sono, viceversa, il cacio sui maccheroni. Non per cucirsi sul petto i galloni della star venerata dalle folle desiderose d’ispirarsi agli ingannevoli portatori d’invulnerabilità. Ma per far sorridere, sognare e riflettere il pubblico proprio con la vulnerabilità connaturata alla creazione di circostanze convertite in rimedi contro la monotonia. Una cura dello spirito che amplia la visione del mondo ed esplora gioie e dolori: la brama dell’iperbole, l’ansia febbrile, l’essenzialità delle note intime. Che penetrano la complessità dell’esistenza. Senza colpo ferire.
1). D / La scuola di tecniche dello spettacolo ti ha insegnato a porre il lavoro sul personaggio al servizio della regìa?
R / Il diploma conseguito al corso di recitazione e aiuto regìa nell’istituto di Claretta Caratenuto, figlia del grande Mario (nella foto), uno dei migliori caratteristi del nostro cinema, mi ha dato senza alcun dubbio una visione d’insieme fondamentale. Nel senso che condividere le stesse corde con un regista, suonare la medesima musica sotto certi versi, costituisce per ogni attore la migliore delle risorse. Sino ad adesso non mi sono mai azzardato a compiere il gran salto, passando dietro la macchina da presa. È un impegno spossante, degno di rispetto. Perché implica la responsabilità di tenere d’occhio l’intero assetto del film. Dalla fotografia alla scenografia, dal montaggio alle prove recitative del cast. Da parte mia cerco di dare una mano concretamente mettendo la presenza fisica e lo slancio per aderire al personaggio a disposizione dei registi che devono poi congiungere il tutto ad altri elementi espressivi. Sono solito scherzarci sopra: noi in fondo abbiamo chi ci pettina, chi ci trucca, chi ci mette in posizione, per stare a debita distanza dalla cinepresa, chi ci guarda, ci controlla, c’indica le mosse da compiere passo per passo. 
2). D / Così facendo il gioco fisionomico della recitazione non rischia di diventare una semplice pedina nello scacchiere evocativo degli autori con la “a” maiuscola?
R / È una pedina autonoma. Che lavora per se stessa in armonia con la scacchiera. Per accordare il tutto, impedendo alle intuizioni artistiche di divenire vezzi e alle soluzioni creative del regista di limitare le sfumature psicologiche conseguite dalla recitazione, è necessario dirigere un film come fosse un’orchestra. L’interprete molto esperto tende ad aggiungere sempre qualcosa di suo sviluppando determinati risvolti del personaggio. La virtù di predisporre con la debita cura dei particolari i vari fattori che si vengono a creare sul set fa sentire ognuno pienamente parte del gioco. Un gioco fatto con precisione certosina ed estremo impegno. Senza lasciare nulla al caso. Affinché l’autore, o regista che dir si voglia, abbia in mano le redini dello spettacolo e ogni elemento, impreziosito dal sentimento creativo che lo guida, funzioni all’unisono.
3). D / Allora gli interpreti non sono, come sostengono alcuni addetti, dei pupazzi e hanno modo, piuttosto, di dire la loro grazie alla nascita di un sentimento creativo che dà l’acqua della vita alla verità delle passioni?
R / Sono pupazzi con un’anima. Almeno si spera. Certamente capaci, quando lavorano di comune accordo con il regista eletto ad autore per le soluzioni stilistiche portate a termine, d’imprimere un tocco personale di un certo tipo alla verità delle passioni cui giustamente fai riferimento. Il carattere d’autenticità, che serve per entrare nel personaggio e garantirgli i giusti accenti realistici, dipende da questo. Ed è una cosa che denota serietà. Serve anche quella. Insieme all’intelligenza di non prendersi tuttavia troppo sul serio. Conoscendo però, al contempo, i sentimenti che s’intende comunicare. È questione di equilibri.
4). D / Conoscere, citando Stanislavskij, vuol dire sentire perciò?
R / Il sentimento, buono o cattivo che sia, resta un mezzo conoscitivo cui non si può rinunciare. Il mio amico Tony Sperandeo (nella foto), in tal senso, nel suo essere viscerale, schietto, impulsivo e profondo, trascendendo gli indugi eccessivamente contemplativi – per penetrare i meandri della psiche umana – è un buonissimo, cattivo maestro. 
5). D / Concordo. Nel ruolo di Tano Badalamenti in “I cento passi” gli bastano pochi minuti per lasciare una traccia decisiva. Con un personaggio biasimevole ma indimenticabile.
R / Recitare accanto a lui è un’esperienza unica. Rappresenta una fortuna assoluta poter assistere da vicino alla tensione che lo anima mentre scende nelle profondità del personaggio che interpreta. In quel caso non è la quantità dei minuti che gli sono concessi ma la qualità che v’imprime a contare davvero. E a fare la differenza. È un uomo in possesso di una generosità illimitata. Ma, dinanzi ad attori vanesi, che se la sentono calla, come si dice a Roma, tira fuori gli artigli. Ha una personalità forte. Tipica di chi si fa rispettare. E di chi, per rispondere compiutamente alla tua domanda iniziale, ricava la sua conoscenza recitativa dalle cose che sente dentro.
6). D / Hai un bell’affiatamento anche con Marco Bocci. Dipende dal fatto che “A Tor Bella Monaca non piove mai” è l’esordio in cabina di regìa di uno che finora ha fatto l’attore, ed ergo tra colleghi ci si capisce, o il valore aggiunto dell’affetto serve ad appianare sul nascere ogni divergenza di stampo gerarchico?
R / Il sentimento dell’amicizia agevola molto il compito di trovare sempre una linea di comprensione sul set affinché il piano di lavorazione proceda secondo i termini prestabiliti. Volersi bene contribuisce a impedire che durante le riprese vi siano ostacoli alla forma unitaria e visiva impressa al racconto dal regista. Gli studi come aiuto alla regìa, ribadisco, mi hanno insegnato che occorre in primo luogo impedire a qualcosa dovuto a un disaccordo, sul piano umano o sotto l’aspetto tecnico, d’influire negativamente sulla realizzazione del film. Un’intesa fraterna sottintende, quindi, il massimo della comprensione che abbisogna perché tutto vada in un determinato verso. Quello giusto, intendo. L’affetto che Marco nutre per il sottoscritto è completamente ricambiato. E solo un attore, specie uno come lui col coraggio di buttarsi in una nuova avventura, piena di ostacoli, ma anche colma di stimoli, può spiegare l’uso che bisogna fare della recitazione e l’importanza di capire come sfruttare il talento degli interpreti. Nella consapevolezza degli sforzi, psicologici e fisici, ai quali sono sottoposti. 
7). D / Sei un attore che parla molto con gli occhi. Nondimeno il tuo ispettore Battiston, nella serie tv “La squadra“, dimostra che l’impiego del dialetto, specie quello diverso dal proprio, costituisce una componente tutt’altro ché accessoria. Basta per gettare nuova luce su certi aspetti del personaggio rivendicando uno specifico status d’autorialità?
R / C’è una storia particolare nella genesi di quel Battiston. Ho mentito spudoratamente sulle mie origini. All’epoca stavo spesso insieme ad Alex, un amico, anche lui, adorabile che ogni tanto ancora sento. Proveniente proprio dal triangolo in Veneto da cui viene l’ispettore della serie. Dopo mesi passati a metterlo in mezzo per la sua calata, sono riuscito ad apprenderne la struttura grammaticale e la fonetica fatte di sillabazioni curiose. Spassose molte volte. Tipo bas-tan-sa (abbastanza). Ma anche le parole tronche – come do-tor (dottore) – e l’intonazione in generale avevano il loro perché. I primi mesi, per dirla schietta, furono un vero inferno. Dovevo studiare parola per parola. Ed era piuttosto faticoso. Specie rendere credibili certi accenti gravi e acuti. Al di là del loro lato divertente. Poi, a lungo andare, ci ho preso la mano ed è diventato tutto abbastanza automatico. Aggrappandomi ad alcune regole – «el xe», al posto di «lui è», la «ve» al posto della «vi», la «se» al posto della particella «si», la «c» pronunciata in un determinato modo – ho trovato la strada per l’immedesimazione. Quella maniera di parlare, che non ricopre mai una funzione di contorno, si è andata via via ad amalgamare con il piglio perbene, un po’ malinconico del personaggio.
8). D / In “Squadra antifurto“, “Squadra antitruffa“, “Squadra antimafia” e “Assassinio sul Tevere” – con Tomas Milian nelle vesti dello sboccato ma genuino commissario Nico Giraldi – l’attore statunitense John P. Dulaney (nella foto), doppiato da Gianni Marzocchi, interpreta il poliziotto Ballarin. Con la faccia da pupo biondo che piace alle serve. Una specie di antesignano di Walter Battiston.
R / Ammazza, aho! Sei un databse: sai tutto. Ed è verissimo. C’era in quel veneto unito al romanaccio di Giraldi un’enorme schiettezza. Una spontaneità che oggi, come sai, hanno ucciso con le nuove tecnologie. Con i social network. Esisteva un modo di vivere la strada che ormai è scomparso. E, al di là della funzione comica, la componente iperpopolare corrisponde a situazioni che sia io che te abbiamo vissuto. Ed è qualcosa che ci portiamo dietro. Al pari al bagaglio di studio e di conoscenze apprese nelle scuole vere e proprie. Il dialetto filmico, quindi, emana verità. Ha una forza evocativa. Pure nelle battute che sembrano ammiccanti e basta, che in realtà sono molto di più di quello. E da là che riparte il gigante buono di Battiston, prendendosela, lì per lì, nella sua entrata in scena, con il parcheggiatore abusivo partenopeo. 
9). D / Cosa ha significato per te, da romano, lavorare a Napoli?
R / Con me, parlando di Napoli, sfondi una porta aperta. Io ho sposato Napoli. Ho sposato la sua cultura variopinta e inesauribile. Il suo sole. La sua trascinante passionalità. Ho sposato mia moglie, soprattutto. Lei è una napoletana verace. Sono un appassionato del dialetto partenopeo da sempre. Napoli, come ha scritto Giorgio Bocca (nella foto), siamo noi. Con i difetti, con la precarietà, con le difficoltà, ma anche con quel tocco di fantasia, legata all’arte di arrangiarsi, e il desiderio di ricominciare perennemente da capo partendo dal passato. Con creazioni linguistiche e battute magnifiche. Napoli è uno specchio di come gli esseri umani sono fatti nel profondo. Vado perciò molto fiero della mia doppia cittadinanza: romana e napoletana.
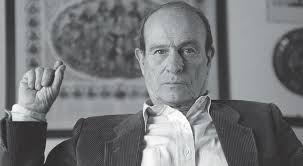
10). D / La forza significante della partenopeità “nun se batte”. Tornando ai silenzi di “A Tor Bella Monaca non piove mai“, il lavoro di sottrazione serve a mostrare cose sennò invisibili?
R / È stata oggetto di ampia riflessione questa tua osservazione. Che mi hai fatto a bruciapelo, con molta spontaneità, faccia a faccia, al termine della conferenza stampa al Cinema Adriano di “A Tor Bella Monaca non piove mai”. Ho pensato: ma sarà una cosa positiva se mi fanno i complimenti per quando sto zitto? Scherzo, ovviamente. È come se tutto il frutto di sentimenti ed emozioni a getto continuo scivolasse negli occhi. Imprimendovi un’energia misteriosa. Che trattiene qualcosa di magico. Io, al contrario, con la mia fisicità ci ho sempre combattuto. Non ho mai trovato un’autentica pace. In “Suburra – La serie” diviene una maschera esteriore. L’involucro di affetti inespressi, sentiti ma combattuti. Bisogna saper poi misurare i soprassalti interiori e liberarli quando è il momento giusto. Allora la fisicità diviene un aiuto. Perché dà sfogo a quello che aleggia nell’aria. Che non si vede. Ma si percepisce dagli sguardi, per l’appunto.
11). D / Le tavole del palcoscenico ti spingono a incentivare più la vivacità dei dialoghi, capaci pure di far ridere, o a conferire al valore evocativo della parola un timbro drammatico?
R / Nel teatro non c’è mai niente di semplice o di scontato. Hai sempre il cuore che ti balla in gola. Per via del contatto diretto con il pubblico che ti restituisce tantissimo. Quello che non si dice mai troppo spesso in merito alla differenza tra cinema e teatro è che sul palcoscenico, quando si recita, senza chiaramente potersi mai interrompere, come accade sul set, il grado di coinvolgimento del pubblico è chiaro come il sole. Il suo modo di vivere lo spettacolo rappresenta un successivo stimolo ad accrescere una professionalità che analizzi sempre meglio le circostanze esteriori e l’azione interiore. Far ridere, infine, non solo è basilare, per il nostro equilibrio, ma anche molto più difficile rispetto al compito di ricreare la verità delle passioni in chiave drammatica. Farlo con l’umorismo richiede una precisione quasi matematica di gag, lazzi, scene, controscene e tempi perfetti. Apprendere al meglio i tempi comici costituisce la sfida più affascinante. E anche quella più appagante. Alleggerire il cuore pesante della gente, in momenti tristi, è un’impresa meravigliosa.
MASSIMILIANO SERRIELLO



















