
A colloquio con Giulio Base su Pessoa, Pasolini e Poliziotti
Scritto da Massimiliano Serriello il . Pubblicato in Cinema, Musica e Teatro.
I MODELLI DELL’ATTORE-REGISTA LEGATO ALL’UNICITÀ DEGLI ECHI CHE CEMENTANO ESTRO ED EMOZIONI
Una conversazione con Massimiliano Serriello
Letteralmente stregato all’epoca dell’età verde dalla lettura di Un grande avvenire dietro le spalle redatto dal compianto Vittorio Gassman sulla scorta della proverbiale arguzia, estranea alle banalità scintillanti dell’insulsa propaganda dei biopic tutto fumo e niente arrosto, Giulio Base (nella foto) parte dalla natìa Torino in direzione Firenze.

Per apprendere alla Bottega teatrale proprio di Vittorio Gassman a respirare l’atmosfera magica del palcoscenico. Dove è buona la prima. Non ci sono ciak. Ed è un po’ come il tango di cui parla Al Pacino alla creatura muliebre attanagliata dall’incertezza in Scent of a Woman di Martin Brest: «commetti uno sbaglio, ma non è mai irreparabile: seguiti a ballare». Il magistero recitativo, frammisto alla fragranza del bagaglio umano, tuttavia agli occhi del proselito fermamente deciso a lasciare il segno non apparteneva ad Al Pacino. Sia pure superlativo. Bensì all’istrionico Vittorio Gassman (nella foto) che in Profumo di donna del nostro Dino Risi seppe ispirare il remake yankee interpretato dal collega italoamericano in virtù della capacità, consolidata dall’alacre commedia all’italiana, di far ridere amaramente e di far riflettere ironicamente. Di pari passo col gioco della finzione scenica. Nella cognizione, frutto dell’energica cultura multiforme, che «l’inglese ‘to play’, il francese ‘jouer’, il tedesco ‘spielen’, il russo ‘igrat’ hanno il duplice valore di recitare e giocare». Secondo Gassman «non c’è attrice più pura della bambina che gioca con la bambola; la veste, la pettina, ricrea attorno a questa sua figlia finta una favola perenne». 
Tuttavia ad attirare Giulio Base, lungi tanto dal pettinare le bambole quanto dallo smacchiare i leopardi e asciugare gli scogli, come si suol dire nell’Urbe, furono i riferimenti al magico sdoppiamento dell’attore con la battuta sempre in canna, la passione per i profili di Venere che l’attorniano, l’amore sincero, incondizionato per gli inobliabili versi di William Shakespeare (nella foto), il grande Bardo, per l’intenso ed evocativo pentametro giambico, rinvenibile nell’unità metrica anglosassone composta da una sequenza intervallata di cinque sillabe ora brevi ora lunghe a forma di formichiere rincarato, con le zampe davanti corte giustapposte alle posteriori lunghe, in modo da dare forza significante ed empito esistenziale a ogni parola. Ai primi approcci con le opere ritenute immortali. Al processo di analisi, all’aspetto fisico, alla destrezza mimica, al versante introspettivo, al risvolto spirituale. Nella consapevolezza tuttavia, sulla scorta dell’acume dell’eclettico maestro intellettuale munito altresì del buon senso d’ascendenza popolare, che, senza nulla togliere ai valori della scuola statunitense, meditata accomodando il Metodo Stanislavskij alle insignite tecniche d’immedesimazione ed estraniazione, il troppo stroppia. Anziché spersonalizzarsi, a caccia d’applausi e nuovi consensi, Giulio Base ha preferito misurare le proprie ambizioni, prima dell’esordio come attore in Misteri di San Pietroburgo per la regìa del guru Gassman, con la trepidazione come spettatore dell’Otello di Shakespeare messo in scena a Torino. Rivisto all’infinito. Assaporando di continuo la crescente tensione, che si taglia sempre col coltello benché sia ben manifesta la piega dei tragici eventi. Nel 1999 le parti si rovesciano. 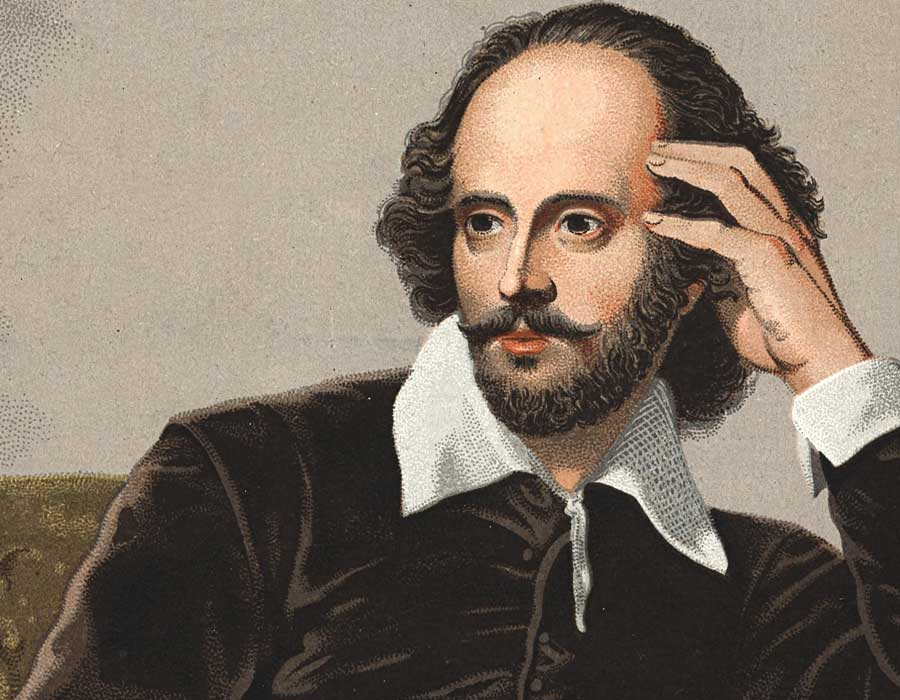
Ed è Giulio Base (nella foto) a dirigere Vittorio Gassman ne La bomba. Ricongiungendolo nel tenero ed eterno gioco della summenzionata finzione scenica con l’ex dolce metà Shelley Winters. Nel ricordo del trasporto giovanile, delle reciproche pizzicate in punta di fioretto nelle rispettive biografie, della pace sancita dalla bontà di fondo. Tonificata dall’ironia. E dall’autoironia. L’esordio in cabina di regìa con Crack, spaccato sul mondo della boxe nella periferia di Roma, diventata nel frattempo la città adottiva, gli permette di esibirsi dietro e davanti la macchina da presa. Comprendendo di possedere più frecce al suo arco caricandosi l’onore e l’onere della riuscita del film sulle spalle. Istruite dalla confidenza con l’alta e la bassa densità lessicale, con le parole piene e le parole in apparenza vuote, coi segnali discorsivi, con gli studi meticolosi, col divertimento suggellato dall’arguzia della commedia dell’arte, trasmessa di bottega in bottega, col training muscolare acquisito nel serrato e pregnante tirocinio, con la danza delle opposizioni. Che manda a carte quarantotto i luoghi comuni. 
Al pari dell’indolenza delle idee prese in prestito. La polivalenza espressiva lo spinge nel 1993 a calarsi nei panni di un facinoroso capo-ciurma neofascista in Teste rasate di Claudio Fragasso. Quasi trenta primavera dopo gira Un cielo stellato sopra i tetti di Roma. Rinverdendo i palpiti per la Noble Art, per i diretti al mento, per gli «uppercut» al volto, alla figura. Lontano dalla crudezza oggettiva dell’università della strada. Per il confronto vis-à-vis di culture agli antipodi. Con la cucina kosher degli ebrei romani giustapposta ad altri appetiti enogastronomici dei giovani abitanti della Città Eterna che, passando dal violoncello alla carbonella, indagano sui trascorsi custoditi in una sbiadita fotografia trovata in soffitta. Chiusi da decenni in una valigetta. Per ribadire, nel ripassare l’emozionante itinerario del tempo perduto, e dopo recuperato, caro a Marcel Proust, la rilevanza della Storia con la “S” maiuscola. Legata al territorio. Alle vie. Alle strade. Alla Shoa. Per non dimenticare. Come non va dimenticato, ci tengo a sottolineare, il Giorno del Ricordo delle foibe. Perché non esistono, né dovrebbero esistere, sul serio, come ribadito dagli storici estranei alle ragioni di partito, guerre tra spettri. Né martiri di serie A e di serie B. Ad andare oltre le intestardite discipline di fazione e le sterili opinioni di schieramento allergiche ai controcampi – che invece nella scrittura per immagini del cinema ricoprono un ruolo di assoluto rilievo, al pari delle correzioni di fuoco da un soggetto all’altro, dei movimenti di macchina da destra a sinistra, a presagire l’irrompere del vento del cambiamento o di qualche emblematico intoppo nell’ordine naturale delle cose, dei carrelli a schiaffo, al servizio del dinamismo dell’azione – glie l’ha insegnato l’incomparabile poetica del sommo scrittore portoghese Fernando Pessoa (nella foto). La raccolta di poesie, i giochi di parole, la tentazione dell’iperbole, le fulminanti intuizioni, la complessa sfaccettatura umana, emanata nelle vesti assai poliedriche di occultista, di solerte conoscitore delle pagine esoteriche tracciate lungo i millenni e i secoli, d’adepto degli ordini segreti mistici, di futurista ed ellenista, sensibile alle vampate avanguardiste e al bisogno di volgere l’interesse al passato, al valore ereditato dalla tradizione, costituiscono per Giulio Base una materia da approfondire palmo a palmo. Un oggetto d’inesausta analisi infinitamente più preziosa delle testardaggini ideologiche, della composizione o della scomposizione di un personaggio, dei copioni da mandare a memoria, della discrezione di scegliere le inquadrature adatte. All’uopo, aggiungerebbe Totò. Per indirizzare lo sguardo degli spettatori sul talento di scrivere con la luce, convertendo i timbri pittorici in avvisi interiori. Per proseguire ad aggiogare l’allegorico vento, a riordinare l’impossibile, a scorgere la poesia nella razionalizzazione dell’assurdo. Perché, come amava ripetere Vittorio Gassman citando Dostoevskij,«due più due fa sempre quattro, ma quanto sarebbe bello se almeno una volta facesse cinque». 
In Bar Giuseppe i conti che non tornano a chi calcola l’interazione tra arte ed esistenza, tra immagine e immaginazione, tra passato e presente con i canoni cartesiani cedono la ribalta ai semitoni. Alla bellezza del silenzio col quale l’anziano protagonista, impersonato con impeccabile misura da Ivano Marescotti (nella foto), spinge i paesani pugliesi infastiditi dalla presenza degli immigrati ad addivenire a più miti consigli. Giulio Base dietro la macchina da presa pedina le vicende del vedovo Peppino, l’assorbimento dell’insofferenza nell’etica della messa in scena. Che si anima nei pertugi del bar, nel disturbante tormentone diegetico da discoteca a tutto volume, nelle sgommate in automobile dei congiunti. Ostili all’attaccamento del vetusto vedovo all’avvenente ed eterea esule africana. Il “cappuccino” sgradito ai figli, nel ricordo della mamma comunque solidale col prossimo, al di là del pigmento cutaneo, la fila di persone che rispondono alla richiesta di un aiutante, come fosse un’audizione per entrare a far parte di un gruppo rock, le quinte di zavattiniana memoria rispetto ad Alan Parker in The Commitmens, ed ergo alla descrizione dei macro e microcosmi sviliti dall’arido tran tran giornaliero, sostenuti nondimeno dalla speranza, non ne costeggiano neanche di striscio la solarità d’animo. La scelta di anteporvi i chiaroscuri, di privilegiare le reazioni mimiche al turbinio delle canzoni del gruppo rock, la musica classica che cadenza lo spettro della solitudine dell’ennesimo Giuseppe, ridivenuto per opera dello Spirito Santo, alla celebrazione del soul, richiama alla mente il pudore, la linearità dell’animo, i coefficienti antispettacolari di Ermanno Olmi. 
Sulle cui orme Giulio Base sembra muoversi governando i fattori espressivi ivi congiunti con la levità allergica a fronzoli od orpelli vari. Prima invece con Il banchiere anarchico (nella foto) Giulio Base aveva accettato la sfida di portare sul grande schermo per la prima volta le dissertazioni, la complessità testuale, lo spiazzamento dell’imbrigliabile Pessoa in merito ad aspetti mentali e qualità naturali. All’ordine naturale delle cose e all’uso illegittimo del potere. Al Bene, al Male, alle doti oratorie, che ghermiscono ed elettrizzano le folle, al fascino esercitato dalla scrittura, alle incongruenze di cui soffre chiunque intenda conciliare l’agire economico col disconoscimento delle convenzioni sociali, alla vanità, all’umiltà, all’incalzante disamina al servizio della linearità dell’animo. Che ritorna in Bar Giuseppe. Declinata nelle emozioni sommesse. Il grido che ne Il banchiere anarchico lacera il predominio dell’intimismo, della compostezza, della precisione geometrica, del bianco e nero iniziale – seguito dall’apposito governo degli spazi, dalle poltrone bianche stagliate nel buio, dall’intesa stabilita insieme al fidato direttore della fotografia Giuseppe Riccobene – crea un inatteso cortocircuito. Uno strappo. Lo stampo teatrale, il riverbero del primo amore, che non si scorda mai, trascende l’origine intellettualistica, il nodo inestricabile della problematica morale, i pareri agli antipodi sull’eredità romantica e sulla ragione illuministica, l’essenza del mito, i rimandi alla sacralità, il sentimento inverso di desacralizzazione, lo sradicamento dalla consuetudine, le ineguaglianze da abolire, i distinguo stabiliti dalla tradizione, l’idiosincrasia per la modernizzazione dell’economia, l’esposizione dei fatti probabilistici e deterministici, la deduzione e l’induzione. 
A presiedere la saldezza delle soluzioni scenografiche, dell’ampia gamma di stimoli cerebrali ed emotivi – proiettati nel tessuto narrativo di un film che sta a Wall Street di Oliver Stone come il mistery La talpa di Tomas Alfredson sta alle pellicole incentrate sulle peripezie dell’elegante Agente 007 – e del largo registro di sfumature crepuscolari c’è la priorità dettata dal sentimento. Dall’egemonia del cuore sul cervello. E al cuore, non ce ne vogliano le pedisseque teste d’uovo emule di Woody Allen, non si comanda sul serio. È chiaro che l’idea di cinema è rispecchiata al meglio dalla saga di James Bond e da Wall Street. Ma il debutto dietro la macchina da presa nasce da uno spettacolo teatrale di Franco Bertini. Diplomato al Laboratorio di esercitazioni sceniche sotto la direzione artistica dell’immenso Gigi Proietti. Inoltre, a parte la dignità formale, il desiderio d’inchiodare l’attenzione degli spettatori avvertiti e d’istruire il pubblico meno attento di solito alla potenza evocatrice degli apologhi dall’aura occulta, restano i contenuti, ed ergo la polpa, la sostanza, allergica alle mere rifiniture, a spingere Giulio Base a fare di necessità virtù. A sopperire al low budget con la ricchezza delle idee. Attinte al nume tutelare ed elaborate giorno per giorno. Per comprendere appieno quel genio poliglotta, trasformista, col gusto dello sberleffo, avvezzo a tendere calappi ai poveri di spirito, a comminare punture di spillo ai falsi eruditi convinti di conoscere a menadito la prosa di Shakespeare senza parlare né capire una parola d’inglese. Non è un caso che Il banchiere anarchico sia approdato nel mercato primario di sbocco della fabbrica dei sogni, indagando sugli incubi del passato riconvertibili in motivi e interrogativi di stretta attualità, accompagnato da un indicativo aforisma di Pier Paolo Pasolini (nella foto): «Nulla è più anarchico del potere, il potere fa praticamente ciò che vuole». Ed è stato un soggetto per un film su una guardia di PS che Pasolini non concretizzò a causa della morte prematura, consumata nell’omicidio all’Idroscalo di Ostia, che ha spinto Giulio Base a mettere in cantiere Poliziotti. Senza ombra di dubbio il suo film più sentito. Più compatto. Nella convergenza della forma con il contenuto. Del cuore con il cervello. A dispetto della pessima accoglienza riservatagli nell’uscita in sala– nell’ormai remoto 1995 – dalla critica ufficiale definendolo «un dramma poliziesco tagliato con l’accetta dove il poliziotto buono è di un’ingenuità disarmante, quello dai modi rudi sembra la versione italica del giustiziere della notte e il cattivo ha tutti i tic del malavitoso da telefilm». 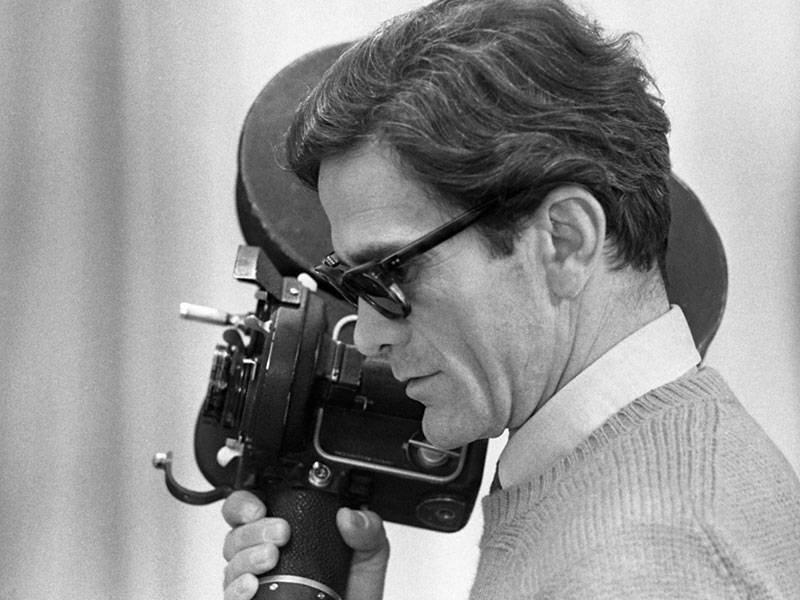
Andando per ordine, senza voler fare l’avvocato d’ufficio, il poliziotto buono Andrea, interpretato tra l’altro con straordinaria aderenza al personaggio da Kim Rossi Stuart, è smarrito, perché la fidanzata casertana gli ha preferito un altro e glie l’ha comunicato per lettera; soffre la solitudine. Ma non è così ingenuo: afferra subito che Lorenzo, lo sbirro del Nucleo Operativo indebitamente paragonato al giustiziere della notte, detto Lazzaro, con la maschera incisiva, virile, densa di Claudio Amendola, è l’artefice dell’abuso di difesa di cui parla il giornale, lo riconosce a una prima occhiata quando lo incrocia, costretto a tagliarsi i capelli dai superiori, biasima Sante Calella, accostato al cattivo dei telefilm, gli fa presente di essere finito prima in prigione e poi in ospedale. Inscenando un suicidio. Ma paga dazio all’introversione. All’ipersensibilità. Arrivando a perdere la vita per essa. Dopo aver accordato fiducia al delinquente abituale affidatogli in custodia dallo Stato in nome del sentimento, della nostalgia, della voglia di razionalizzare l’assurdo. È vero: quel vagabondo, che dice di aver viaggiato in tutto il mondo e di parlare quattro lingue, che gli ha insegnato a giocare a scacchi, ci poteva pensare prima. Però scatta ugualmente la molla dell’empatia. Claudio Amendola nel ruolo di Lazzaro (nella foto con Giulio) ricorda Marlon Brando da giovane: massiccio nel fisico, cerbiattesco in alcuni sguardi. Uniti alle occhiate severe. E, a dispetto dei modi rudi, attribuitigli usando le scorciatoie del cervello, comprende subito che Andrea ha buttato la lettera della fidanzata fuori dal finestrino del treno che li porta a Torino. Certo in qualche modo se ne approfitta anche lui: chiede di affiancarlo nel piantonamento in ospedale per potersi assentare, coperto dall’amico, e restituire pan per focaccia allo spacciatore che ai tempi avvelenò il fratello. La sua reazione per lavare l’onta del suicidio di Andrea, che non resiste alla vergogna di essersi fatto fregare da un uomo per cui la parola d’onore conta meno del due di picche, passa attraverso il mix di dolore ed empatia, di rabbia e decisione. 
Il dinamismo dell’azione, una tantum, va a braccetto con l’aura contemplativa. E l’atteggiamento guascone, scaltro, opportunista di Sante Calella, impersonato da Michele Placido, riverbera l’esacerbazione della selezione naturale darwiniana, le peculiarità psichiche del maneggione. Alieno al cliché albergante nell’immaginario collettivo: per far cadere Andrea nella rete Sante assume un atteggiamento a tratti protettivo. Quasi paternalistico. Non trapela il ghigno mefistofelico. L’effigie dell’abusante tagliata realmente con l’accetta. Bensì la scaltrezza, camuffata da umanità ferita, del predone privo di rimorsi. Forte coi deboli. E debole coi forti. L’autentico fatto di cronaca – con Vincenzo Rizzi (Andrea), suicidatosi per Pasolini in quanto un ragazzo «obbediente» in un mondo di «disobbedienza», Cosimo Marra (Lazzaro) deciso a riacciuffare con le sue sole forze il responsabile Pietro Merletti (Sante) – scompagina la paura dei registi a corto di coraggio nel mettere le mani avanti con il leitmotiv dell’avvertenza di rito: «Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale». E persino la prammatica della didascalia introduttiva del cult d’impegno civile Le mani sulla città di Francesco Rosi («I personaggi e i fatti qui narrati sono immaginari, è autentica invece la realtà sociale e ambientale che li produce»), a dispetto della cifra stilistica più svelta ad appaiare la registrazione documentaria degli eventi ai rapporti di causa ed effetto della creazione artistica frammista al coraggio etico, passa in secondo piano. Ricondotte ad Andrea, al poliziotto che sulla falsariga degli (anti)eroi della letteratura francese ha perso la vita per eccesso di sensibilità, affiorano alla mente le parole di Pasolini nei confronti dei manifestanti universitari esacerbati dalla rivoluzione sessantottina: «Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti! Perché i poliziotti sono figli di poveri. Vengono da periferie, contadine o urbane che siano. Quanto a me, conosco assai bene il loro modo di esser stati bambini e ragazzi, le preziose mille lire, il padre rimasto ragazzo anche lui, a causa della miseria, che non dà autorità. La madre incallita come un facchino, o tenera, per qualche malattia, come un uccellino; i tanti fratelli, la casupola tra gli orti con la salvia rossa (in terreni altrui, lottizzati); i bassi sulle cloache; o gli appartamenti nei grandi caseggiati popolari». 
La filmografia di Base è ampia ed eterogenea – da Lest a Lovest, da Il pretore a Mio papà, da La coppia dei campioni a Il banchiere anarchico, da Bar Giuseppe a Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma – ma Poliziotti resta l’opera in cui la soluzione tecnica, affidata ora al fuoco selettivo ora all’uso dello slow motion, provoca in maggior misura l’attenta partecipazione del pubblico. Lo spinge a riflettere. Lo tiene sui carboni ardenti. Lo conduce nelle discoteche, nei cimiteri, negli ospedali, nei night, nei luoghi storici, nelle alcove. Pone in risalto la breve speranza avvilita dalla manipolazione relazionale, il senso dell’amicizia, il bisogno dell’azione e della reazione come antidoto al dubbio e allo sconforto. Sembra che Base abbia trasmesso ad Andrea la sottile, rivelante introversione che affiora nella complessità dei versi mandati ad effetto dal grande Pessoa. Ed è perciò interessante ripercorrere con lui le tappe segnate dalla personalità, dalla spersonalizzazione, dall’umanità.
**** **** **** **** **** **** **** **** ****
1) D / Nel 2013 ti è stato riconosciuto dal Guinnes Worlds Records il primato della corsa più lunga della storia del cinema per il documentario Cartoline da Roma che hai realizzato nel 2007. Ritieni che i film, come 1917 di Sam Mendes, girati con un unico piano-sequenza paghino dazio allo sfoggio stilistico o vige un’autentica urgenza espressiva?
R / In Cartoline da Roma il ricorso al piano-sequenza era dettato dalla volontà quindi di dispiegare quella corsa, in una sorta di variazione di Caro diario a piedi se vuoi, attraverso Roma nello spazio di una sola mattinata. Anche per cogliere per intero, passo per passo, senza stacchi, la luce presente nelle prime fasi del crepuscolo. Con il primo raggio di sole dell’aurora. L’alba nera. Filmare il momento dell’inizio della luce prima del sorgere effettivo del sole era per me importante. Un’urgenza espressiva. Come l’hai giustamente definita. Volevo inchiodare l’attenzione dello spettatore senza servirmi delle soluzioni di continuità offerte dagli stacchi di montaggio. In modo da sostituire l’impressione di dare continuità con la continuità vera e propria. Hai citato 1917. Lo ritengo un film bellissimo. Necessario. Ma gli preferisco Arca russa (nella foto) di Aleksander Sokurov. 
2). D / Anch’esso realizzato per intero con un unico long take. A parer mio ben più necessario rispetto a 1917 perché ripercorre la Storia attraversando le sale del Palazzo d’Inverno. Cogliendo quella che i cinefili chiamano aura contemplativa. Parlando di cinefilia – intesa come amore per il cinema – è un’altra necessità per chi come te fa cinema a differenza degli appassionati che lo amano e dei critici che lo giudicano?
R / Fare cinema la ritengo soprattutto un’enorme fortuna. Che mi permette un risveglio felice ogni mattina. Perché faccio un lavoro che amo. E anche nella fase più critica dell’isolamento dovuto alla lotta contro la pandemia, a dispetto dei lamenti pressoché unanimi degli altri, giusti o meno, io mi alzavo felice lo stesso. Al di là della situazione luttuosa a livello nazionale e mondiale. Per cui ovviamente provavo e provo tristezza, incertezza. Ma la certezza dell’amore per il cinema e la felicità garantita dalle visioni pure se casalinghe, invece che in sala, sono state più forti. Ed è per questo, Massimiliano, che chi fa cinema per amore, e non solo per necessità, ama vedere i film. Perché pensa a come fare i propri. Entra in empatia con le storie dei film che vede. Per merito della tecnica, dello stile, della passione che gli altri registi, specie i grandi maestri, ci mettono. Ed ecco perché la cinefilia è necessaria. 
3). D / Tornando al tuo documentario su Roma, al di là del titolo, i luoghi che mostri non sono cartolineschi ed esornativi. Bensì necessari ed evocativi. Che ascendente esercita la geografia emozionale sul desiderio di trascendere attraverso la scrittura per immagini del cinema l’esaurimento dei temi trattati?
R / Il cinema, come anche la lingua italiana, non può essere ricreato di punto in bianco. Come in un certo senso ha fatto Federico Fellini. Grazie alla propria forza immaginifica: non c’è dubbio. Ma anche grazie ad ampi budget. Che gli permettevano di metterla in pratica. La creatività assoluta necessita pure dei mezzi per passare dalla teoria alla pratica. Secondo me quando ci si mette all’opera dietro la macchina da presa bisogna prendere partito dalla natura, dall’architettura, dalla forza evocativa dei luoghi designati a location. E quindi dalla geografia emozionale. Che effettivamente consente di andare oltre il fatto che è stato già detto più o meno tutto.
4). D / È stato già detto tutto. È vero. Ciò nondimeno, perdona il bisticcio della parola, il cinema può continuare a dire, ed esprimere attraverso la scrittura per immagini, tutto e il contrario di tutto?
R / Certamente sì. È stato detto tutto. Ma non è stato visto tutto. Se accostiamo la visione alla scrittura per immagini. Questa nuova forma di comunicazione ha raggiunto ormai l’apice nell’epoca in cui viviamo. Penso, oltre al cinema, alla tv, alle serie, alle web serie. Ormai scrivere per immagini è un’abitudine. Una tendenza di punta. Anche nell’uso dei social. Da Facebook a Instagram. Su WhatsApp, in maniera vanagloriosa ed esibizionista talvolta, oppure in modo spontaneo, persino interessante, emerge la forza dell’immagine. Nell’applicazione informatica, nella messaggistica il diletto di associare alle parole le immagini va per la maggiore. Perché le immagini comunicano spesso e volentieri più delle parole. Poi un conto è il dilettantismo, un altro è il professionismo. Che permette di fare le cose sì con diletto, inteso come il piacere di svolgere una professione che si ama, ma anche con una cognizione di causa avvalorata dalla tecnica e dall’urgenza espressiva.
5). D / Ed è per questa ragione che in Bar Giuseppe ricorri a quella che Robert Bresson (nella foto) chiamava la «bellezza del silenzio»? Il che non vuol dire che tu debba fare dei film muti o che imiti Bresson. Anche perché sarebbe dura: Bresson, come si dice a Roma, nun se batte.
R / Mi fa comunque piacere che tu abbia fatto riferimento a Robert Bresson. Lo ritengo un Maestro. Con il lavoro di sottrazione, rinunciando ad aggiungere particolari ridondanti e ammiccanti, ha mostrato le enormi possibilità del mezzo espressivo costituito dalla scrittura per immagini. Magari mi potessi anche solo avvicinare ai suoi livelli: il rapporto tra rigore ed emozione che emerge dalla scrittura per immagini quando si crea togliendo, e non aggiungendo, è uno stimolo importante per potersi districare e fare qualcosa di diverso. Il silenzio, da questo punto di vista, è un’arma in Bar Giuseppe: tutti dicono la loro, sbraitano, spesso cambiano pure idea; Giuseppe, invece, è stabile nel suo saper ascoltare, nello scegliere l’eloquenza del silenzio al posto del vacuo frastuono di chi fa tanto clamore con poca sostanza. Il silenzio, oltre che uno stimolo ai fini dell’etica della messa in scena, è una specie d’allenamento. Per lo sfrondamento. Per l’essenzializzazione. Per l’emozione pura. Profonda. O quanto per meno per provarci. Perché riuscirci non è certo facile. 
6). R / Alcuni proseliti del lavoro di sottrazione ce l’hanno con il teatro portato al cinema: lo definiscono teatro imbastardito. I seguaci del cinema d’autore stigmatizzano chi fa sia cinema sia televisione. Quando ho chiesto a Michele Soavi se fare televisione fosse una palestra, ed ergo un allenamento, mi ha risposto che è una guerra. Da combattere giorno per giorno. Tu cosa pensi: oltre al teatro, la tv tempra la concezione di un cinema che, invece di mettere in risalto le cose, le suggerisce?
R / Condivido il pensiero di Michele: è soprattutto una battaglia. Ma in parte anche una palestra. Nel senso che quando devi rispettare un piano di lavorazione molto serrato, simile a una catena di montaggio, ti alleni. Tieni all’erta la capacità di fare tante cose insieme. Di stabilire velocemente a che altezza, a quale distanza tenere la macchina da presa. Di decidere il taglio dell’inquadratura. Di curare i dialoghi, l’illuminazione, i primi piani in interni, i campi lunghi in esterno. Di occuparsi in tempi brevi dei vari fattori espressivi. Troppi ce ne stanno. Riuscirci è un bel training. La guerra consiste nel difendere le proprie idee, nonostante tutto. Mantenendo fede all’impegno preso. Per realizzare una miniserie. Oppure una serie con tante puntate. Dove vige la regola di «buona la prima!». Perché non si va tanto per il sottile. A quel punto, quando torni a fare cinema dopo le battaglie, i compromessi, la palestra dell’esperienza televisiva, comunque utile, se ti è rimasta quella lieve, non voglio dire cialtroneria, ma sfacciataggine, birbanteria, arte di arrangiarsi, dai, la inserisci nel modo di rapportarti col grande schermo, appiattendo lo stile, ormai adeguato ai diktat del piccolo schermo, oppure cerchi sin dal principio di fare qualcosa di diverso dalla semplice fiction. Lottando, se non altro, per riuscirci. E se ci riesci, assapori la bellezza di scrivere con le immagini in maniera emozionante e talvolta persino poetica.
7). D / Hai parlato di sfacciataggine. Ma la capacità non certo di passare da palo in frasca, ci mancherebbe, ma di congiungere cultura alta e cultura bassa, mescolanze di antiretorica ed enfasi o drammatica o intessuta d’impareggiabile verve è un lascito di Vittorio Gassman che riusciva sia a essere uno squisito interprete shakespeariano di prim’ordine sia a impersonare gli esilaranti cialtroni nelle commedie nostrane.
R / Mi ha sempre spinto a fare le cose. E soprattutto a osare. D’altronde, nello spronarmi, era solito ricordare che poetare significa fare. Indica, sin dall’etimologia, quindi non solo la bellezza della poesia, la forza significante del fulcro drammatico di un occhio mai troppo pesante, bensì vigile nel conferire alla costruzione narrativa un senso di mistero e di speranza, ma anche l’audacia di provarci. Di scegliere una strada difficile ma appagante nello spingere lo spettatore a immaginare, a sognare, ad abbeverarsi alla cultura. Tanto a quella alta quanto a quella bassa. Gassman ci teneva a far capire che l’ingegno non cascava dal pero. Io, nel bene e nel male, ho seguito questo lascito. Magari ho fatto troppo. Mi sono cimentato in veste di attore, regista, ho fatto la tv, ho fatto il teatro, a cui resto molto affezionato, ho fatto tanto e a volte ho pensato poco.
8). D / Però, insomma, resti fedele al senso etimologico del verbo ‘poieo’.
R / Che significa fare dal nulla. E quindi inventare. Ed è qualcosa di diverso dall’arte di arrangiarsi. Che comunque Vittorio, da quell’attore versatile, geniale ed erudito che era, ha impersonato benissimo. Così come ha scritto pagine memorabili nella storia del teatro padroneggiando la cultura alta. Ed è anche quello un lascito, un esempio, uno stimolo a cui guardare. Tuttavia la poiesis (ποίησις) rimane lo stimolo principale che mi ha spinto a fare, a perseverare. Poi i risultati non spetta a me giudicarli. Io sono in ogni caso davvero fiero di aver beneficiato dell’insegnamento di un tale Maestro.

9). D / Tra l’altro sei stato l’ultimo regista ad averlo diretto. Ed è un fiore all’occhiello. Tengo in grande considerazione il contributo fornito dai caratteristi che, seppur condannati a ruoli fissi e a poche pose, rendono memorabili i loro personaggi invece di colorirli solo: è un fiore all’occhiello anche essere stato l’ultimo regista ad aver diretto Mario Brega (nella foto)?
R / Grandissimo Mario! Una vera forza della natura. Una simpatia unica. Un romano de Roma che mi faceva ammazzare dalle risate. Che ha divertito milioni di spettatori. Con una gran faccia. Ma non lo scopro certo io. Poi sono legatissimo al film, Crack, in cui ho diretto Mario. Era il mio esordio. Come ben sai. Mario era perfetto per il ruolo dell’allenatore di boxe severo. Con la battuta pronta. Poi che te lo dico a fare?!: conosci le battute a memoria. Come non volergli bene. D’altronde voglio molto bene a Crack. Segna il passaggio dal teatro al cinema. La convivenza della recitazione con la regìa. Ero un ragazzo. N’è passato di tempo. 
10). D / Crack fu maltrattato dalla critica specialistica. Nonostante l’apprezzamento del pubblico e i premi assegnati dagli addetti ai lavori. Quei giudizi critici così severi bruciano ancora?
R / Te l’ho detto: ero un ragazzo. E credevo in quello che facevo. Ci credevo fermamente. Pur essendo alle prime armi. Lì per lì ci rimasi male: certi giudizi rasentarono la cattiveria. Una critica ci può stare. Per carità. A ciascuno il suo. Il ruolo del critico dal punto di vista orientativo può essere importante per la sensibilità di chi legge. Col tempo ho imparato a farmi scivolare addosso i giudizi critici che ritengo cattivi. Ancor prima che ingiusti. Però il tempo, per rispondere compiutamente alla tua domanda, non ha lenito del tutto il fastidio e in un certo senso la sofferenza per quelle stroncature. Ma la voglia di fare, e di seguire il lascito di Gassman sul senso di poetare, non ha subìto flessioni.
11). D / Servirebbero critici come Anton Ego in Ratatouille per orientare il pubblico nei confronti del nuovo che ha bisogno di sostenitori. Ma è più facili trovare critici forti coi deboli o coi nuovi e deboli coi forti ed esperti. Il giudizio che formulo da critico nei tuoi confronti è che a parer mio hai più frecce al tuo arco come attore. Ti ricordo comunque volentieri ne Il portaborse di Daniele Luchetti in cui interpretavi l’autista di Nanni Moretti che mette ko Silvio Orlando. Anche al povero Francesco alias Gianmarco Tognazzi in Crack il tuo Wolfango (nella foto) glie le suona sode. Quel rapporto dominante si è ripetuto in Teste rasate. Claudio Fragasso ha saputo cogliere la vostra alchimia e ritrasferirla in un film di successo?
R / Claudio ha visto Crack e ha colto in effetti il carattere d’autenticità dell’intesa stabilita con Gianmarco. Il risultato è frutto sia di una grande amicizia che si è creata lavorando insieme sia di un processo d’incubazione cominciato con le prove a teatro, col contatto col pubblico – attirato da Gianmarco che seppur giovane era già un nome di richiamo in quanto figlio d’arte – ed è infine collimato nel film. L’alchimia stabilita è basata su un aiuto reciproco: lui era a digiuno di tecniche recitative; aveva talento, ma non era ancora un attore formato. Io, al contrario, provenivo comunque dalla Bottega di Gassman. Gli ho dato quindi delle imbeccate. Per aderire al personaggio. Che subisce. A differenza del mio. Che tende a dominare. Pur nascondendo delle fragilità. Con Teste rasate il mio Saverio (detto Il Führer) è diventato più dominante e carismatico agli occhi del personaggio incarnato da Gianmarco. Che lo subisce. E n’è affascinato. 
12). D / Per interpretarlo hai adottato una sotto-recitazione. È stata una scelta tua o di Claudio Fragasso?
R / È stato Claudio a volere che Saverio fosse interpretato per sottrazione. Più con gli sguardi che con le parole. Io quando recito, riconoscendo al regista la facoltà di prendere le decisioni espressive fondamentali alla riuscita del film, mi metto a disposizione. Proprio perché sono anch’io regista. Da attore spengo tutti gli altri file. Sono soltanto il soldatino al servizio della persona chiamata a dirigere, ad esprimersi ed elaborare le notazioni psicologiche, le tecniche, gli accenti realistici, lo straniamento, il potere fascinatore della fotografia e della recitazione. Come attore faccio quello che da regista chiedo ai miei interpreti: diventate colori del mio pennello; «non cercate di diventare pennello» gli ripeto spesso. Quindi quando faccio l’attore per gli altri registi mi trasformo, se ci riesco ben inteso, nel colore che loro vogliono da me. 
13). D / A proposito del colore: la capacità di scrivere con la luce suggella la tua cifra stilistica. Completandone la scrittura per immagini. Che imbeccate hai dato al tuo direttore della fotografia ne Il banchiere anarchico per dare alle soluzioni luministiche la sensazione della chiarezza e dei chiaroscuri?
R / Ho conosciuto Giuseppe Riccobene (nella foto) nel 2004 quando era un operatore steadicam. Comunque qualificato. Nella mia miniserie televisiva San Pietro il suo compito è stato appunto quello dello steady-man. E ha fatto bene il suo lavoro. Poi ha cominciato a crescere sotto il profilo professionale, ad approfondire, a studiare. E io l’ho stimolato e seguito in questo percorso. Infine mi riconosco il coraggio di avergli dato fiducia di averlo fatto debuttare come direttore della fotografia ne Il banchiere anarchico. E quindi in un film a cui tengo moltissimo. Giuseppe ha ripagato appieno questa fiducia. Prima ci eravamo preparati con zelo ed entusiasmo: gli avevo fatto vedere foto, ritratti. Al supporto del racconto. E della capacità, dici bene, di scrivere con la luce. Ed è stata una scrittura soddisfacente. Uno strumento espressivo in linea con le mie aspettative. Tanto che ho chiamato Giuseppe per curare la fotografia pure di Bar Giuseppe. 
14). D / Sei stato il primo autore di cinema a portare Pessoa sul grande schermo. Mia moglie è brasiliana e quindi sento il poeta portoghese alla stregua d’un conterraneo. D’altronde era latino. Pensi che, potendolo realizzare, un film ad alto budget, con tanti attori, invece che due, come Il banchiere anarchico, rispecchierebbe meglio gli «eteronomi» ovvero, secondo l’etimologia (ètero – dal greco ἕτερος, ἑτερο – «altro, diverso» – e onoma «nome»), quell’ampio ventaglio di prospettive?
R / Magari! Pessoa ha tirato fuori così tante personalità artistiche, così tanti autori dentro di sé, così tante vite, per certi versi, che di racconti per il grande schermo me ne vengono in mente un sacco. Proprio perché è un autore che adoro: l’ho letto, l’ho ripassato, l’ho letto in originale. Quel poco che non è stato tradotto in italiano, l’ho letto in portoghese. Non senza un certo sforzo. Con il dizionario alla mano ho voluto analizzare ogni suo verso. Viceversa se dovessi rifare domani Il banchiere anarchico, anche con un budget alto, lo rifarei nello stesso identico modo. In quel territorio tra sogno e realtà, tra teatro e cinema. Dove la parola regna sovrana. È stato davvero un omaggio al testo. Oltre che una riflessione a tutto tondo sul potere del denaro. 
15). D / Tra gli altri nomi di Pessoa – che ne so, tra epicurei ed ellenisti, tipo Ricardo Reis, scusa la pronuncia, tra avanguardisti e bucolici – quale sceglieresti per un kolossal coi piedi ben piantati, anziché d’argilla, e la stessa necessità?
R / Hai citato Ricardo Reis, che forse tra i suoi eteronimi è il mio preferito. C’è un romanzo meraviglioso di José Saramago. Che s’intitola L’anno della morte di Ricardo Reis. Saramago non ama solo Pessoa ma una delle costole di Pessoa e racconta questo ultimo anno di vita di quel personaggio con una scrittura sublime. Sarebbe bellissimo convertirla in una scrittura per immagini.
16). D / C’è qualcosa della personalità, della spersonalizzazione, dell’ipersensibilità e dell’introversione nascosta ma rivelante di Pessoa nel personaggio d’Andrea di Poliziotti e in quella tecnica di straniamento usata per girargli attorno perché il mondo gli sta crollando addosso quando Sante si dà alla fuga e la geografia emozionale la fa da padrona con la sala cinematografica che proietta True Lies?
R / Sicuramente. Ho parlato con Cosimo Marra. Che in Poliziotti diventa Lazzaro. E mi ha detto che Vincenzo Rizzi, il vero Andrea, era veramente un bravo ragazzo. Un figlio di un poliziotto. Ligio al dovere. Ai vincoli di sangue. Con dei suoi sogni. Forse irrealizzati. E ci hai preso: l’ho collegato, costruendo il film, all’introversione di Pessoa. Al concetto di spersonalizzazione. Tanto che il sogno di Andrea in Poliziotti era fare il pittore. La sequenza che ho girato nella Galleria San Federico di Torino, con la scritta di True Lies – il film, per altro bellissimo, che davano in quei giorni – alle spalle di Andrea mentre il movimento di macchina che gli gira intorno ne cattura la disperazione, è un omaggio al cinema. Perché è in quella galleria è nato il cinema in Italia.
17). R / Poliziotti è la summa delle tue necessità espressive: la geografia emozionale, l’appartenenza, l’amore per il cinema e Pessoa. È un film intenso con un finale in sordina. Perché?
R / Perché dopo tante emozioni, volevo togliere. Per giustapporre alla magniloquenza – dei sentimenti, dei legami di sangue, del suolo che diventa personaggio, dell’amicizia, della spersonalizzazione, della reazione – un finale senza sottolineature sopra le righe. Ma con l’ambiente e il contegno del personaggio interpretato da Claudio Amendola (nella foto), che ha riconsegnato Sante alla giustizia, in grado di assorbire la tensione drammatica grazie alla capacità rivelativa sotto le righe. In cui sono i silenzi a parlare. 
18). D / Ed è Amendola alias Lazzaro, simbolo a mio avviso di una sana reazione all’ingiustizia in nome dell’amicizia e del rispetto per l’ipersensibilità, a cementare quella capacità. È stato il colore giusto per scrivere con la luce, Giulio?
R / Massi, sì. Nel modo più assoluto. Mi è piaciuto lavorare con Claudio Amendola. Dirigerlo. Perché è un attore e un uomo sensibile ma forte. Gentile ma deciso. Un collaboratore attento e disciplinato. Con un cast così è stato più semplice fare un film diverso dalle opere a tesi. Che ti dicono come la devi pensare. Preferisco lasciare, come anche in San Giuseppe, delle risposte inevase agli spettatori per farli riflettere. L’alchimia creata con Poliziotti la porto nel cuore. Sarei contento di dirigere ancora Claudio. E ristabilire quell’intesa.
MASSIMILIANO SERRIELLO


















