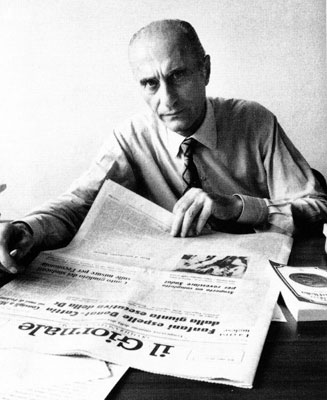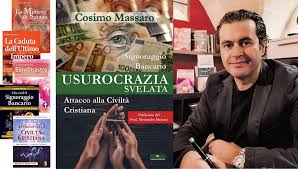Una data da ricordare senza guerre tra fantasmi
IL GIORNO DEL RICORDO BUSSA ALLA COSCIENZA DELL’ONESTÀ INTELLETTUALE
«Quando comincia una guerra la prima vittima è sempre la verità. Quando la guerra finisce le bugie dei vinti sono smascherate, quelle dei vincitori diventano Storia».
L’aforisma del compianto giornalista ligure Arrigo Petacco (nella foto) coglie in flagrante i seguaci dell’ipocrita livellamento ugualitario che, con buona pace dei princìpi propugnati a ogni piè sospinto, vanno in escandescenze dinanzi al ritegno di equiparare Norma Cossetto ad Anna Frank. Il martirio della giovane istriana, violentata e ingoiata dalla Madre Terra che non volle rinnegare a causa dell’ondata d’impressionante ferocia degli aguzzini titini, non vale nulla, agli occhi degli imperterriti faziosi ottenebrati dalle ragioni di partito, rispetto all’atroce sofferenza dell’adolescente ebrea tedesca. Vittima dell’inesorabile Terzo Reich. 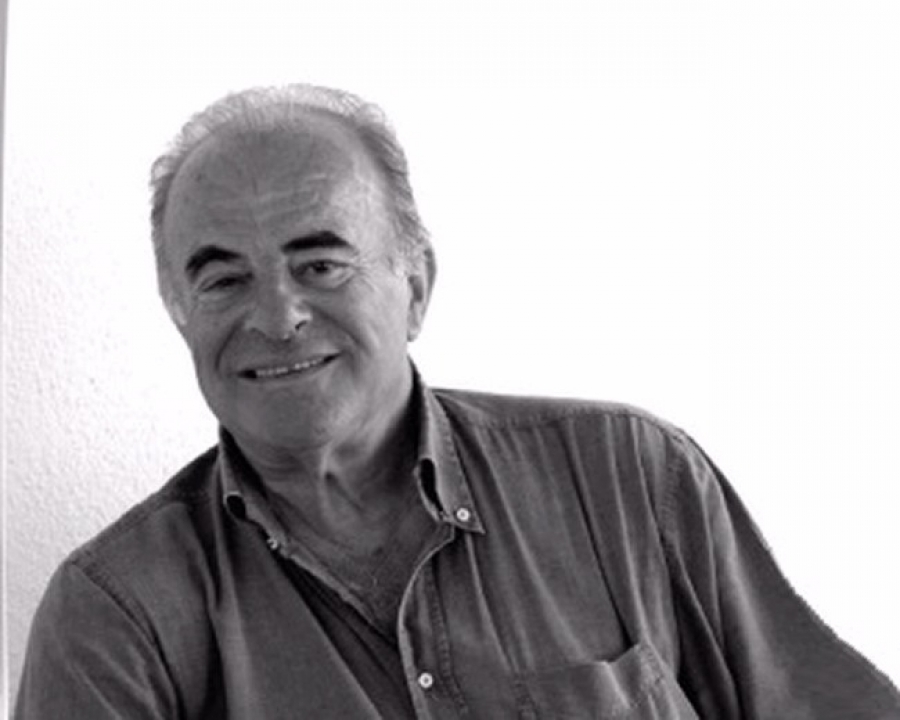
L’onestà intellettuale, alla base del codice deontologico di qualsivoglia divulgatore deciso ad anteporre il concetto di aletheia all’impasse degli schieramenti ideologici, ha il sacrosanto dovere di censurare l’inesausta guerra tra spettri. Non per fare pari e patta, come si dice a Roma. Ma per assicurare la priorità allo svelamento della benedetta verità. Anziché all’arcinota attitudine di portarsi l’acqua al proprio mulino, a costo di negare l’evidenza.
Ad Arrigo Petacco, autore d’innumerevoli pubblicazioni incluso il libro L’Esodo, lo rimpiangono, oltre agli aderenti all’onorevole egemonia dello spirito sulla materia, scudo tuttavia talora degli impulsivi soverchiatori, anche i degni rifugiati che, come sostiene giustamente Dino Messina, scelsero di essere italiani due volte.
Inorridirsi di fronte ad abominevoli slogan sulla Shoa, che condannano gli artefici a corto di cuore e materia grigia alle fiamme dell’inferno, per poi sghignazzare con indegna lestezza sul tiro al piccione ai danni della salma dello schietto scrittore Giampaolo Pansa (nella foto) non ha alcun senso. A meno ché non si voglia conferire un nobile avallo alla smania di trascinare la coperta tutta da un lato. Qualcosa resta sempre scoperto. 
Talora il gap prevede il dolore autentico di gente estranea ai cali di personalità, in merito agli slanci sensibili che tralignano o in cieca indifferenza o, ancor peggio, in compiaciuta empietà. Con tanti cari saluti ai pistolotti sui migliori angeli dell’indole umana caldeggiati dagli epigoni smemorati del 16º presidente degli Stati Uniti Abraham Lincoln.
Sulla medesima stregua della Civiltà, l’attaccamento ai vincoli di sangue e di suolo non c’entra nulla con le banalità scintillanti della scaltra ed ergo menzognera propaganda. Lo prova la solennità civile rappresentata oggi dal Giorno del Ricordo. Per tenere bene a mente, a caratteri di fuoco, il rispetto che si deve ai testimoni della fede in quei vincoli. Il rispetto per i pacifici individui finiti negli inghiottitoi, dovuti all’erosione dell’acqua sulla roccia. Trasformati nel punto di orrida raccolta di vittime neglette. Negate per anni e anni.
Comunque al di là delle immancabili polemiche, nella piena consapevolezza che Pansa, considerato un voltagabbana dagli equilibristi intenti a rivoltare la frittata, è morto nel calduccio del suo letto, invece di coniugare l’esistenza all’imperfetto in un campo di concentramento nazista o nei lager di Tito, è meglio spegnere il fuoco degli eterni battibecchi. Continuare ad alimentarlo è un tragico paradosso. L’ennesimo.
Quando, a distanza di due primavere dall’abbattimento del Muro di Berlino, in coincidenza con la dissoluzione dell’Unione Sovietica, Francesco Cossiga (nella foto), allora Presidente della Repubblica Italiana, attraversò il confine con la Jugoslavia, creato dal Trattato di Parigi al termine delle crudeli ostilità, per inginocchiarsi nei pressi della foiba di Basovizza, l’atto di pentimento fu ritenuto uno sconfinamento. 
Quando Pansa nel libro La notte dei fuochi mise in risalto le ragioni dei vinti ai tempi del biennio rosso, seguito dal Ventennio mussoliniano in trionfo con la marcia su Roma, le maggiori testate scrissero che tornava a indagare legittimamente su un passato che rischiava di divenire la premessa del presente. Che era capace di rivedere il Novecento e le ragioni degli altri con la fulgida virtù dell’obiettività.
Con l’uscita poi del controverso best seller Il sangue dei vinti, apriti cielo! Gli attacchi aprioristici a Pansa, senza leggere nemmeno una riga della sua debita fatica letteraria, sono piovuti ‘a manetta’. La voce degli sconfitti in quel caso doveva restare silente per i gendarmi della Memoria, alfieri fino a poco prima della libertà d’espressione.
Piero Fassino si distaccò dall’acefalo schieramento compatto per spendere parole doverose, quantunque inopinate, e rendere così onore alla necessità d’illuminare gli angoli bui della Storia chiedendo idealmente venia. Il lungo tempo del silenzio cedeva dunque il passo al rilascio della medaglia commemorativa ai parenti delle vittime occultate a Istria, a Fiume, in Dalmazia. Sull’onda di una violenza pianificata. Cui seguì l’Esodo giuliano dalmata.
Adesso il revisionismo, il negazionismo, il giustificazionismo, che considera le azioni d’infoibamento per opera dei titini la ‘giusta’ reazione ai soprusi perpetrati in precedenza dagli “ustascia” capitanati dall’autocrate Ante Pavelicn e al tradimento dei “domobranzi”, i ragazzi di leva schierati per il tricolore nostrano, servono a poco. C’è qualcosa che ha molto più rilevo della conta dei caduti, delle opinioni discordanti sulla resistenza civile, sul concetto di tradimento agli occhi di coloro che abbracciarono le armi contro lo straniero, per il giuramento di fedeltà al re, per mettere fine ai progetti di sterminio d’ambo le correnti. La riflessione implica l’uso del cervello. La carica di pietas chiama, viceversa, in causa il cuore.
La visione del documentario This Is My Land… Hebron ha spinto i reazionari lineari ad alzarsi dalle poltrone del cinema con un soprassalto di sdegno nei riguardi dei prevaricatori rei di vantarsi dell’omicidio di Cristo per intimidire gli indesiderati palestinesi. Il giusto riguardo lo merita altresì il docu-film For Sama incentrato sull’atto d’amore compiuto da una madre, attraverso la registrazione nuda e cruda della guerra in Siria, per la figlia nata ad Aleppo sotto l’assedio d’uno Tsunami di fuoco. L’addio ai luoghi dell’anima penetra nel cuore di chiunque lo abbia quell’organo. Sopravvalutato e sottovalutato secondo i casi.
Chi non sente nessuna pietas per la gente – fascista, antifascista, cattolica, atea, di destra, di sinistra, agnostica – costretta ad abbandonare il suolo natìo, affrontando un viaggio nel Bel Paese fatto d’infinite ed empie umiliazioni, è chiamato, con un monito alieno alle repliche puerili, dalla coscienza, ammesso ve ne sia una nell’intimo dei negazionisti, a togliersi il cappello, a metterselo sul petto, a chinare il capo. Nel ricordo delle spoglie, spacciate inizialmente per detriti chimici dagli alfieri del depistaggio e dell’orrido occultamento indefesso, recuperate dall’impressionante inghiottitoio situato presso l’Albona d’Istria a Vines (nella foto). 
I cinefili rammenteranno l’atipico western Soldier Blue di Ralph Nelson. È d’altronde pressoché impossibile togliersi dalla testa e dal cuore il momento in cui Candice Bergen (nella foto), con in braccio una creatura squartata durante l’attacco dei sanguinari cavalleggeri del Colorado all’inerme villaggio Cheyenne a Sand Creek, grida al coscritto che aveva commemorato i caduti al termine di un previo assalto indiano: «Adesso non la reciti più la poesia, soldato blu?!». 
Ed è questo il punto. Per comprendere l’oscillazione della sensibilità orientata ai partiti presi. A differenza del regista Maximiliano Hernando Bruno (nella foto), estraneo alle pretese di legittimazione dei delitti commessi tanto in nome della Civiltà quanto in quello della Patria, che ha realizzato lo splendido Red Land – Rosso d’Istria per onorare la Memoria di Norma Cossetto. 
L’accoglienza ricevuta a La Spezia lo ha ripagato sul piano in primis morale ed etico della campagna d’odio costruita altrove per lordare l’uscita in sala del film d’impegno. Prodotto senza l’erogazione del Ministero dei Beni culturali.
Il ricordo della firma del contraddittorio Trattato di pace che ha costretto gli esuli di Pola, capoluogo dell’Istria, ad affrontare la manifesta avversione dei compatrioti italiani, lasciandosi alle spalle una città esanime, necessita d’un Omero sobrio ed essenziale. Per riflettere sul destino degli esuli in partenza, in fuga, in viaggio con la morte nel cuore, sotto la neve, sui negozi coi sigilli, sulle finestre chiuse a Parenzo, a Rovigno e ad Albona. Sulla montagna di sedie messe una sopra l’altra (nella foto). 
Né va passato sotto silenzio il treno della vergogna, col convoglio preso a sassate a Bologna e il latte per le creature a bordo versato sui binari. E così la caserma “Ugo Botti” a La Spezia adibita per decenni ad abitazione ai limiti dell’assurdo per gli esuli istriani sgraditi. Meno che mai si può ignorare il barbaro modus operandi col quale mogli, figli, genitori di presunti collaborazionisti, ma finanche partigiani restii a prestare giuramento alla dittatura di Tito, furono disposti a ridosso delle foibe. Con i polsi legati dietro la schiena. Congiunti gli uni agli altri col fil di ferro. In attesa del colpo di pistola indirizzato alla prima fila. E i restanti destinati a precipitare nel baratro in preda a un’indescrivibile agonia.
Gli esuli sgraditi però a lungo andare sono divenuti graditi in quel di La Spezia. La mamma di Andrea Manco (nella foto), originaria di Pola, una volta fuori dalla caserma, inseritasi in una comunità in grado di fare ammenda, non volle rovinare al figlio il sogno tricolore all’epoca della vittoria della Nazionale di calcio nei Campionati Mondiali del 1982. Crescendo avrebbe appreso la verità segreta sulle foibe, sull’Esodo, sui disguidi delle sensibilità coi cali di personalità, su una Storia celata sui banchi di scuola. Allora voleva che la sua creatura gioisse come tutti gli altri bimbi inebriati dal successo patrio. Ricordate La vita è bella di Roberto Benigni? È un regalo il tenero trucco, a fin di bene, che solo un genitore può fare per il sangue del suo sangue. 
Oggi, nel Giorno del Ricordo, a La Spezia, Andrea, in veste di Delegato Provinciale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, ha reso onore a quei vincoli di sangue e di suolo. Che non hanno bisogno dell’arma dell’aggressione, della reazione, della polemica, della giustificazione. Perché hanno dalla loro la fragranza della Verità. L’antidoto migliore ai miasmi dell’ipocrisia.
E se le persone con la sensibilità che va a corrente alternata si fossero frattanto rimesse il cappello in testa, sbadigliando con indifferenza, se lo ritogliessero cospargendosi il capo di cenere. È l’onestà intellettuale, non certo il sottoscritto o altri, a imporglielo bussando alla loro coscienza senza unghie né tantomeno nocche. Bensì con la linearità dell’anima. Per non dimenticare. Né oggi né mai. A Dio piacendo.
MASSIMILIANO SERRIELLO





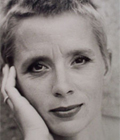




 Il decremento recente (2.444,6 miliardi di euro rispetto ai 2.446,8 miliardi del mese di dicembre) costituisce l’aglietto di romanesca memoria col quale consolarsi degli amari risvegli dai dolci sogni di maggiori incrementi e meno spese correnti.
Il decremento recente (2.444,6 miliardi di euro rispetto ai 2.446,8 miliardi del mese di dicembre) costituisce l’aglietto di romanesca memoria col quale consolarsi degli amari risvegli dai dolci sogni di maggiori incrementi e meno spese correnti.