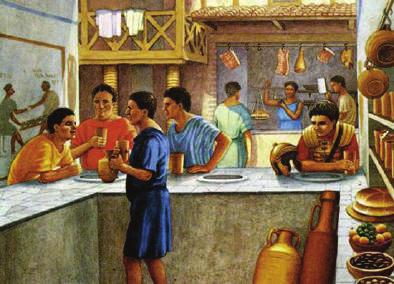Computer e smartphone sono diventati i migliori amici dell’uomo, e se è cambiato il modo in cui ascoltiamo la musica o guardiamo l’orologio, ed il cellulare è diventato un apparecchio tuttofare, molta parte del merito (o no?) è sua.
Alcuni aspetti della vita di Steve Jobs sono stati avvolti dal mistero, a partire dalla nascita che avvenne il 24 febbraio 1955, ma dove? C’è chi dice che sia nato a San Francisco e chi sostiene che il piccolo Steven Paul sia nato in Wisconsin. Apple si è sempre rifiutata di fornire questa informazione, finchè la biografia ufficiale svelò l’arcano confermando la nascita di Jobs a San Francisco. I genitori erano entrambi due studenti universitari; il padre, Abdulfattah “John” Jandali, di origine siriana, sarebbe poi diventato un professore di scienze politiche, la madre invece era americana. Entrambi temendo di non poter garantire un futuro dignitoso al proprio figlio, decisero di darlo in adozione. «Voleva che fossi affidato a una coppia di laureati» raccontò Jobs in un discorso. «Quando scoprì che la mia madre adottiva non aveva finito il college, e il marito neppure il liceo, si rifiutò di firmare le carte. Finché non le garantirono che sarei andato all’università».
Come stabilito nel “patto di adozione” nel 1972 Steve Jobs si iscrisse al Reed College, in Oregon; ma ben presto capì che quei corsi non erano interessanti e che la vita del college era troppo costosa per le casse di famiglia. Così decise di lasciare i corsi ufficiali e di seguire solo quelli che gli interessavano tra cui quello di calligrafia, dove imparò tutto su scrittura, lettere e caratteri. Queste conoscenze sarebbero state alla base, molti anni dopo, delle capacità tipografiche e soprattutto stilistiche del Macintosh.
Per risparmiare lasciò la camera del dormitorio facendosi ospitare da amici, iniziò a raccogliere bottiglie di Coca-Cola vuote per restituirle ai venditori e avere in cambio cinque centesimi, arrivò a fare 10 km a piedi per raggiungere il tempio Hare Krishna dove, la domenica, si mangiava gratis. Secondo Leander Kahney (autore della biografia non autorizzata Nella testa di Steve Jobs, Sperling & Kupfer) provò anche una dieta a base di sole mele, nella speranza che ciò, e chissà perché, gli permettesse di non lavarsi.
Tornato in California, Steve rispolverò la passione per l’elettronica iniziando a lavorare per Atari, uno dei primi produttori di videogame. In seguito con il suo amico e collega Steve Wozniak, decise di mettersi in proprio e nel 1976 fondò la Apple Computer. Sede della società era il garage di casa, il logo una mela morsicata, capitale sociale poco, molto poco. Per finanziarsi Jobs fu costretto a vendere il suo furgone Volkswagen, mentre Wozniak la sua calcolatrice scientifica.

Sulla scia di questo primo successo arrivò l’Apple II, il primo computer fatto e finito, in modo che una volta tirato fuori dalla scatola, poteva essere pronto da usare, senza nessuna parte da montare. Successivamente arrivò Apple III che risultò un flop a causa dei problemi di surriscaldamento. Nel progetto non era stata prevista la ventola di raffreddamento perché a Jobs non piaceva, ritenendola poco elegante.
Nel dicembre 1979 visitò il centro ricerche della Xerox, dove stavano studiando un sistema che avrebbe permesso di comandare i computer attraverso semplici menu a icone. Fu la svolta, e proprio grazie a questa idea Jobs e il suo team riuscirono a trasformare il computer in un elettrodomestico alla portata di tutti. Nel 1984 venne lanciato il Macintosh, il primo computer controllato da due nuovi accessori: la tastiera e un nuovo apparecchio battezzato mouse. Le quotazioni della Apple schizzarono alle stelle, ed iniziò l’eterna disputa tra i fan della Mela e quelli che utilizzavano computer di altre aziende. Alla Apple nacque anche la particolare figura del “Mac evangelista”, un tecnico “mistico” con la missione di convincere amici e parenti della superiorità del Macintosh rispetto al resto.

Riguardo alla vita privata e sentimentale sembra che a vent’anni fosse fidanzato con Joan Baez, icona della musica folk americana e già compagna di Bob Dylan, uno dei suoi miti. Secondo Alan Deutschman, autore di un’altra biografia non autorizzata (I su e giù di Steve Jobs), la storia sarebbe finita perché la Baez sarebbe stata troppo vecchia per avere un bambino. Un rapporto complicato, quello con la paternità; quando nel 1978 la sua prima ragazza Chris Ann gli comunicò di essere incinta, lui non fece una piega e reagì come se la cosa non lo riguardasse. La figlia Lisa nacque così in una comune. Nel 1991, durante un rito buddhista, Jobs sposò Laurene Powell con cui avrebbe poi messo al mondo tre figli.
Nel frattempo il rapporto con Apple iniziò ad incrinarsi; dopo continui contrasti con l’amministratore dell’epoca, nel 1985, Jobs fu costretto a dimettersi. Proprio lui che quella realtà l’aveva creata in garage e resa una compagnia da 2 miliardi di dollari e 4 mila dipendenti, veniva messo alla porta, perché ritenuto improduttivo e fuori controllo. «Essere licenziato da Apple» raccontò in seguito, «fu la cosa migliore che potesse capitarmi. […] Mi liberò dagli impedimenti permettendomi di entrare in uno dei periodi più creativi della mia vita». Di sicuro non se ne rese conto subito.

Anche la Pixar si rimise in sesto con il debutto, nel 1995, nelle sale cinematografiche americane di Toy Story, primo film realizzato completamente con sistemi di animazione digitale. Fu un successo. Il primo di quello che sarebbe diventato ben presto il più importante studio di animazione di Hollywood.
Tornato al timone della Apple, Jobs si trovò ad affrontare una profonda crisi finanziaria e lo fece ricorrendo ai licenziamenti di massa. Sempre secondo una delle biografie non allineate, sembra che bloccasse i dipendenti negli ascensori, interrogandoli sul loro ruolo in azienda. Se a Jobs la risposta non piaceva, potevano essere licenziati anche su due piedi. Una pratica che divenne famosa con l’espressione “essere stevizzati”. Jobs era sì famoso per le sue intuizioni folgoranti, ma al tempo stesso aveva un carattere difficile, pignolo ed egocentrico.
Proprio queste caratteristiche del suo carattere, secondo i suoi fan, sono il segreto delle sue vittorie. Dal rientro in azienda non ha più sbagliato un colpo. Nell’ottobre del 2001 ha presentato l’oggetto che ha cambiato il nostro modo di ascoltare la musica: l’iPod. Qualche anno dopo nacque iTunes, il negozio virtuale dove si possono scaricare dischi e canzoni si legalmente, quindi a pagamento, dal web con il computer er poi esser copiate nel proprio iPod ed essere ascoltate ovunque. Un fenomeno mondialeche Apple ha celebrato nel 2010 dopo aver tagliato il traguardo dei 10 miliardi di canzoni scaricate.
Nel 2004 gli venne diagnosticato un rarissimo tumore al pancreas. «I dottori mi dissero di mettere ordine nei miei affari» raccontò a una classe di studenti, «e questo significa prepararsi a dire ai figli in pochi mesi ciò che pensavi di poter dire loro in dieci anni. Significa dire addio». Dopo l’operazione si rituffò negli affari decidendo di lanciare, o meglio di inventare, un iPod capace anche di telefonare.

L’iPhone divenne un oggetto di culto da subito, il giorno in cui venne lanciato ne furono venduti 500 mila e con l’iPad, venne creato addirittura un nuovo mercato.
La malattia tornò di nuovo quando Jobs aveva iniziato a condurre una vita più “tranquilla” abbracciando completamente il buddismo. Si era dato uno stipendio di appena un dollaro l’anno, anche continuando a possedere molte azioni Apple e godere di vari benefit. Il 17 gennaio 2011 Apple annunciò che Steve Jobs aveva chiesto un nuovo congedo medico, precisando però che sarebbe rimasto CEO e, continuando a occuparsi delle principali questioni strategiche ma sostituito per le questioni di tutti i giorni da Tim Cook. Il 24 agosto si dimise da amministratore delegato di Apple annunciando di voler chiedere al Consiglio di Amministrazione la conferma di Tim Cook come suo successore. Morì il 5 ottobre 2011, a 56 anni, e fu sepolto nell’Alta Mesa Memorial Park di Palo Alto, insieme ad altri imprenditori dell’alta tecnologia informatica, come il co-fondatore di HP, David Packard e l’ingegnere Frederick Emmons Terman, con i quali Jobs lavorò per alcuni mesi estivi come dipendente all’età di 13 anni.