
“FINE Pena: ORA”, un libro di Elvio Fassone
per meditare e riflettere su “FINE Pena: MAI!”
Scritto da Francesco Ricci il . Pubblicato in Costume, Società e Religioni.
Alcune considerazioni sul “Carcere a Vita”
_______________di Francesco Ricci *
Quando sentiamo pronunciare la parola storicizzare in relazione a un libro, pensiamo solitamente alla necessità di calare il testo in questione nel contesto linguistico e storico che gli è proprio. Non farlo è estremamente dannoso, dal momento che può generare fraintendimenti e alimentare errori.
Un esempio in tal senso ci viene offerto dalla magistrale lettura che Gianfranco Contini dette del sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare, appartenente alla “Vita nova” di Dante. Il grande filologo e critico in un acuto saggio metteva in guardia il lettore, tra le altre cose, anche dall’interpretare il verbo parere (tanto onesta pare, e par che sia una cosa, e par che della sua labbia) come sinonimo di sembrare: “pare non vale già ̔sembra ̓, e neppure soltanto ʿappare, ma ̔appare evidentemente, è o si manifesta nella sua evidenza ̓”. Insomma, ciò che di sé Beatrice manifesta, deve essere inteso come qualcosa di oggettivo, non di soggettivo.
Personalmente sono convinto che un’uguale attenzione a quella che è la specificità di un’epoca o di un periodo – specificità storica, culturale, sociale, politica – debba essere all’opera anche quando l’esegesi e la riflessione concernono non già un testo letterario, come può essere il sonetto dantesco, bensì l’ordinamento giuridico di un Paese.
In gioco, stavolta, naturalmente, non ci sono i significati linguistici, a partire dal lessico; piuttosto, c’è l’efficacia delle norme e dei principi – delle regole di condotta – che disciplinano l’organizzazione e la vita dello Stato.
Non solo la lingua, infatti, tanto quella parlata quanto quella scritta, cambia ed evolve nel tempo, ma anche l’ordinamento giuridico conosce mutamenti, trasformazioni, adattamenti.
Scrivo ciò dopo avere concluso la lettura di “Fine pena: ora” (Sellerio, 2015) di Elvio Fassone, magistrato, componente del Consiglio superiore della magistratura, per due legislature senatore della Repubblica. Un libro, questo, molto bello, a tratti commovente, che narra la nascita e la conclusione di una corrispondenza durata ventisei anni – un periodo lunghissimo – tra un giudice (Elvio Fassone) e un ergastolano (Salvatore), condannato per quindici omicidi e altri delitti vari.
Non un’opera di fantasia, sia chiaro, ma una storia vera, drammaticamente vera, che ha fine col suicidio del carcerato: “La lettera che segue non mi è mai giunta, perché egli non l’ha scritta. Ma sono convinto che Salvatore ha avuto questi pensieri, nell’ora in cui ha preso la decisione di togliersi la vita ed ha organizzato la sua attuazione”.
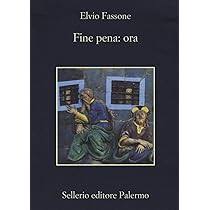 Di grande interessa risultano anche le pagine poste in appendice al volume e organizzate in nove brevi capitoli: Abolire l’ergastolo?, Le resistenze emotive, I precedenti, Gli ostacoli: i crimini efferati… , … e il cumulo di meccanismi attenuativi, Le difficoltà di un intervento radicale, “Ce lo chiede l’Europa”, Qualche proposta praticabile, Non dimenticare Abele. Pagine che, sebbene nascano come riflessione condotta a partire da una storia alla quale Elvio Fassone ammette di essere “legato emotivamente”, tuttavia si segnalano per l’equilibrio, la chiarezza, l’estrema onesta di giudizio.
Di grande interessa risultano anche le pagine poste in appendice al volume e organizzate in nove brevi capitoli: Abolire l’ergastolo?, Le resistenze emotive, I precedenti, Gli ostacoli: i crimini efferati… , … e il cumulo di meccanismi attenuativi, Le difficoltà di un intervento radicale, “Ce lo chiede l’Europa”, Qualche proposta praticabile, Non dimenticare Abele. Pagine che, sebbene nascano come riflessione condotta a partire da una storia alla quale Elvio Fassone ammette di essere “legato emotivamente”, tuttavia si segnalano per l’equilibrio, la chiarezza, l’estrema onesta di giudizio.
Il referendum del 17 maggio 1981, che vide la sconfitta di quanti proponevano l’abrogazione dell’ergastolo, il disegno di legge presentato con prima firmataria la senatrice Salvato, nel 1997, che intendeva sostituire il carcere a vita con la reclusione non superiore ai trent’anni, le sentenze della Corte costituzionale costituiscono i momenti “istituzionali” – che nell’appendice di “Fine pena: ora” sono tutti ripercorsi – della discussione di un tema, che ora riaffiora, ora scompare dal dibattito politico, ma che mai cessa di parlare nel sacrario della coscienza di ciascun uomo di buona volontà: ha senso privare per sempre della completa libertà una persona, si fosse anche macchiata del peggiore dei crimini?
Rinvenire una risposta certa e, soprattutto, definitiva a me pare difficilissimo, forse impossibile. Storicizzare però la questione, come Gianfranco Contini invitava a fare a proposito della lingua letteraria, può esserci d’aiuto. Altrimenti, il rischio è quello di subire il condizionamento di argomentazioni contrarie (a favore o a sfavore della pena perpetua), ciascuna delle quali appare sufficientemente forte da essere meritevole di essere accolta.
 Elvio Fassone, ad esempio, sottolinea a più riprese il fatto che ciascun uomo nel corso della sua esistenza è soggetto a cambiamenti: “nessun individuo, noi compresi, è uguale a quell’“io” che era venti o trenta anni fa”. Perfino chi possiede una visione radicalmente negativa dell’uomo, difficilmente è portato a ritenere una persona o completamente buona o completamente cattiva: siamo tutti fatti di un tessuto misto.
Elvio Fassone, ad esempio, sottolinea a più riprese il fatto che ciascun uomo nel corso della sua esistenza è soggetto a cambiamenti: “nessun individuo, noi compresi, è uguale a quell’“io” che era venti o trenta anni fa”. Perfino chi possiede una visione radicalmente negativa dell’uomo, difficilmente è portato a ritenere una persona o completamente buona o completamente cattiva: siamo tutti fatti di un tessuto misto.
Da questo punto di vista, San Paolo, che da persecutore dei cristiani divenne l’apostolo delle genti, possiede un valore paradigmatico. Lo stesso protagonista di Fine pena: ora, col trascorrere degli anni appare trasformato, non è più quello che era quando entrò in carcere. Lui ne è convinto (“Finalmente ho parlato con il direttore del carcere, e gli ho fatto notare che non sono più il Salvatore di un tempo, voglio prendere la quinta elementare, e voglio fare il corso di ebanista”) e ne è convinta anche l’Autorità, che gli concede il primo permesso (“Salvatore dispone di due giornate consecutive, con rientro notturno e con l’obbligo di accompagnarsi con un assistente che lo attende all’uscita”). La pena non deve essere solamente pena – è scritto nell’articolo 27 della Costituzione –, ma deve mirare alla rieducazione, attraverso la quale passa la possibilità del reinserimento e della risocializzazione del detenuto.
Vero è, però, che la questione-ergastolo può essere avvicinata anche da un altro lato, meglio, da un differente punto di vista, che non è quello del colpevole, bensì della vittima e dei suoi cari. In fondo, è lo stesso autore, nel capitolo conclusivo dell’appendice, a invitare a non scordarsi di Abele (Non dimenticare Abele).
Mentre chi è condannato all’ergastolo, infatti, riconosce la propria colpa e si ravvede – può riconoscere la propria colpa, può ravvedersi –, chi ha subito la sua violenza non c’è più. È morto. Privo del presente, è privato del futuro. Il tempo per lui ha cessato di scorrere, si è fatto ventre sterile, pianta che non dà frutti.
Abele non ha né avrà figli. Caino, si legge nel libro della Genesi, si sposa e ha un figlio, di nome Enoch. Abele no, Abele non ha eredi.
Tutto nasce e tutto muore con lui, non c’è apertura alcuna sul domani semplicemente perché non c’è domani per lui. Non solo. Ma il carico di sofferenza di chi ha perduto un genitore o un figlio o un compagno, che gli è stato strappato con la violenza e dalla violenza, siamo sicuri che col tempo scema?
Siamo sicuri che l’esistenza di chi resta, una volta che il lutto è stato elaborato, riprende a scorrere placidamente e la pena si fa di giorno in giorno più lieve, al punto da poter accogliere senza né rabbia né sgomento che il responsabile di tutto ciò torni libero?
O forse ci sbagliamo e diamo il nome di vivere a quello che in realtà dovremmo chiamare sopravvivere?
Personalmente reputo che entrambe le posizioni – quella che affronta la questione nell’ottica di chi è stato condannato al carcere a vita e quella che affronta la questione nell’ottica della vittima – meritino rispetto e attenzione. Proprio per questo, però, scegliere tra le due possibilità risulta difficilissimo. E allora, quale argomento, ammesso che esista, può indurci a conservare il “fine pena: mai”? Quale a trasformare il “fine pena: mai” in “fine pena: ora”?
Di argomenti ne rivengo uno solo: l’osservazione imparziale di quella che Niccolò Machiavelli in un denso capitolo del Principe appellò “verità effettuale”, vale a dire “realtà effettiva”.
Ebbene, se getto uno sguardo sine ira et studio sull’attuale società italiana, ritengo di poter affermare che non è questo il tempo di eliminare l’ergastolo dal nostro ordinamento giuridico. A partire dalla metà degli anni Settanta, infatti, come già aveva perfettamente colto Pier Paolo Pasolini (clik qui),- il “paesaggio umano” del nostro Paese è cambiato, ed è cambiato in peggio (“Questo è un paesaggio diverso. Qui c’è la voglia di uccidere. E questa voglia ci lega come fratelli sinistri di un fallimento sinistro di un intero sistema sociale”).
Non soltanto la violenza si è fatta più efferata e si è diffusa, in percentuale significativa, anche tra i minorenni, ma è divenuta spesso gratuita, fine a se stessa, senza alcuna ragione che sembri giustificarla e, sovente, senza che colui che vi si abbandona provi la benché minima risonanza emotiva.
Citare e ricordare il terzo comma dell’articolo 27 della Costituzione (“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”) è, dunque, sempre opportuno, per evitare ogni confusione tra castigo e vendetta. Ma non si deve, per ignoranza o per convenienza, tacere il fatto che la pena non assolve unicamente alla funzione rieducativa, ma anche a quella retributiva e a quella di difesa sociale.
Su questo punto la Corte costituzionale si è pronunciata con chiarezza, si pensi alla sentenza del 22 novembre 1974, n. 264 (“non vi è dubbio che dissuasione, prevenzione, difesa sociale, stiano, non meno della sperata emenda, alla radice della pena”).
La sicurezza dei cittadini e il trattamento umano dei detenuti (che attualmente, in Italia, raggiungono le 62000 unità) meritano entrambi uguale considerazione: Abele non è meno figlio di Adamo ed Eva di quanto lo sia Caino.
 *FRANCESCO RICCI, Fiorentino, classe 1965, vive a Siena
*FRANCESCO RICCI, Fiorentino, classe 1965, vive a Siena
ove è docente di letteratura italiana e latina, nonché autore di
numerosi saggi di critica letteraria, dedicati in particolare al
Quattrocento (latino e volgare) e al Novecento.



















