
La Consul Press intervista Pippo Franco sul valore dell’arte e dell’umorismo
Scritto da Massimiliano Serriello il . Pubblicato in Cinema, Musica e Teatro, Arte, Cultura ed Eventi.
IL PROFONDO SENSO D’APPARTENZA E LA LEVITÀ IRONICA DI PIPPO FRANCO
Una conversazione con Massimiliano Serriello
Quando gli capitano sotto gli occhi, ne resta sempre conquistato: l’immediatezza espressiva connessa al timbro stilistico delle vignette, il dono della sintesi, la forza significante ad appannaggio dell’allegra deformazione caricaturale, l’implicita contemplazione del reale avvertita senza concedere alcunché all’infeconda enfasi grafica, l’innesto degli spassosi giochi di parole, gli elementi segnaletici riscontrabili nell’alacre cura dei dettagli rientrano appieno nelle corde del duttile e intramontabile Pippo Franco (nella foto). Giunto da poco al considerevole traguardo delle ottantuno primavere col famoso sorriso sulle labbra. Insieme alla sana leggerezza che trae linfa dal valore terapeutico dell’umorismo, dall’equilibrio preservato dallo slancio dell’empatia, dalla capacità d’impreziosire l’opportuno livello di comprensione sulla scorta dell’imprescindibile autoironia. Lontano anni luce dall’accidia del corredo d’idee sottratto di nascosto all’altrui ingegno, dal deleterio nonché goffo delirio d’onnipotenza, innescato dalle ingannevoli sirene del successo, dagli illusori luoghi comuni e dai pesanti restringimenti. 
L’assennatezza di Italo Calvino (nella foto) in merito a «il planare sulle cose dall’alto, senza avere macigni sul cuore», né darsi per vinti prendendo sottogamba nell’altalena di scoramento ed euforia dell’esistenza l’anelito vitale della tonica levità, fa parte integrante della visione a trecentosessanta gradi di Pippo Franco. All’epoca dell’età verde disegnare fumetti per i cugini transalpini, servendosi del classico leitmotiv di Mandrake e l’Uomo Mascherato per sopperire a qualche disguido dell’ultimo minuto, gli ha insegnato a prendere spunto dagli antesignani dei cinecomics. Con gli effetti chiaroscurali dell’ombra che cammina sulla falsariga della maestria di scrivere con la luce, tipica della fotografia al cinema, e dell’affabile continuum sensoriale garantito dalla successione movimentata in chiave narrativa dei fumetti all’interno degli appositi riquadri. In maniera simile ai raccordi di montaggio nella fabbrica dei sogni. 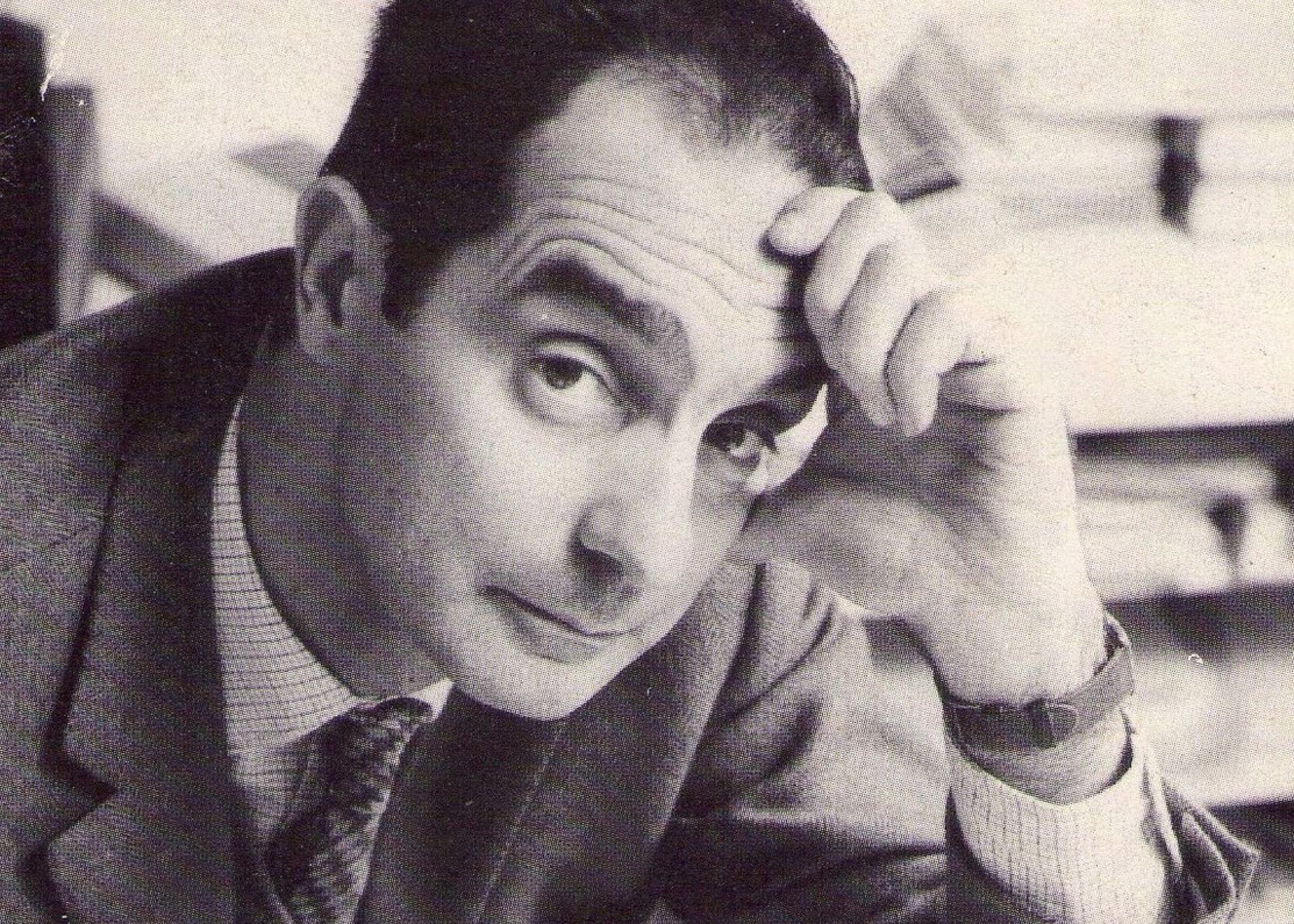
I codici visuali appartenenti alla pittura d’avanguardia sono stati fonti d’ispirazione e di guadagno in precedenza. Da ragazzo. Incline allora ad anteporre alla letteratura disegnata lo spirito d’innovazione legato ai mutamenti prospettici, alle contrapposizioni soggettive, all’inquadratura parziale della realtà. L’angelo custode rappresentato dal sesto senso gli ha presto suggerito di piantare baracca e burattini: i suoi colleghi e amici pittori erano schiavi dei propri demoni privati; il rovescio della medaglia tralignava la vivacità culturale in un opprimente sentimento d’insicurezza, d’inquietudine. Esacerbato dai fumi dell’alcol. Dall’irrimediabile obnubilazione dell’intelletto a causa delle feroci sostanze stupefacenti. Meglio conservare la mente lucida. A vantaggio d’una vita lunga e festosa al posto di una breve e tragica. Come il pur celebrato Mario Schifano (nella foto). Aggregato durante l’indispensabile gavetta nella medesima compagnia. Destinato ad alimentare la fantasia d’innumerevoli proseliti con le sue opere postmoderne, gli affreschi visionari, le sfumature rivelatrici degli enormi quadri realizzati con smalti e acrilici. Colpevole, nondimeno, alla resa dei conti, di privilegiare l’invadente richiamo dei profili di Venere in carne e ossa, gli input libidici, l’edonismo, l’inesorabile tunnel dell’eroina, dell’estasi malaugurata. Con buona pace del focolare domestico. Degli allievi cui tramandare arte e mestiere di bottega in bottega.

A Pippo Franco gli alti e i bassi, le frenesie, le impennate, le rovinose cadute degli artisti, tutto genio e sregolatezza, non passavano neanche per l’anticamera del cervello. Non intendeva andare anzitempo a ingrossare i cavoli. Gli eccessi, lavorando di cesello senza sosta per poi correre la cavallina sino allo sfinimento, non erano roba per lui. Al pari degli asservimenti, delle discipline di fazione, delle cocciutaggini dottrinali. In medio stat virtus. Glie lo avevano insegnato, implicitamente, senza accorgersene, i suoi numi tutelari in campo pittorico: Renato Guttuso (nella foto) e Giulio Turcato. Due guru agli antipodi. Acerrimi rivali. Assidui frequentatori della trattoria dei fratelli Menghi a un tiro di schioppo da Piazza del Popolo. Chiamata altresì l’Osteria dei Pittori. Deus ex machina delle rispettive officine-covo nel centro dell’Urbe. Divisi dalle impuntature autoreferenziali, dall’amor proprio, dalle figurazioni dell’arte astratta contrapposte alla crudezza oggettiva. Dallo scintillio dell’universo immaginario in attrito col talento di catturare nel reale l’attimo fuggente. 
Sensibile ovviamente al gentil sesso, estroverso, coriaceo, oculato, abbastanza coi piedi per terra da non costruire deleteri castelli di sabbia, col tangibile rischio di lasciare i quadri come acconto nelle trattorie capitoline, Pippo Franco seppe farsi strada in veste di cantautore e musicista. Al posto dell’effigie affascinante ma al contempo inquietante dell’Urlo di Munch (nella foto) ha prediletto il suono confidenziale della chitarra, l’accoppiamento delle parole piene, ricche d’acume mordace, l’appeal dell’avanspettacolo. Con cui i fuoriclasse della comicità, sull’esempio del Principe Antonio de Curtis, in arte Totò, spingevano il pubblico a «patire di piacere».  L’ampio riscontro conseguito sul piccolo schermo nel 1973 con il varietà Dove sta Zazà in prima serata condotto con Gabriella Ferri (nella foto) gli fece toccare il cielo con un dito. Ma senza montarsi la testa. Quando la sensibile e torrenziale Gabriella, simbolo per antonomasia della canzone romana, coniugò la vita all’imperfetto, Pippo Franco spese per lei parole tutt’altro che di circostanza. Dettate dall’affetto, dalla riconoscenza, dall’intesa sul palco, negli studi televisivi del Programma Nazionale, in trattoria, nelle tavole quadrettate e imbandite, nell’università della strada.
L’ampio riscontro conseguito sul piccolo schermo nel 1973 con il varietà Dove sta Zazà in prima serata condotto con Gabriella Ferri (nella foto) gli fece toccare il cielo con un dito. Ma senza montarsi la testa. Quando la sensibile e torrenziale Gabriella, simbolo per antonomasia della canzone romana, coniugò la vita all’imperfetto, Pippo Franco spese per lei parole tutt’altro che di circostanza. Dettate dall’affetto, dalla riconoscenza, dall’intesa sul palco, negli studi televisivi del Programma Nazionale, in trattoria, nelle tavole quadrettate e imbandite, nell’università della strada. 
Anche il ricordo alla Chiesa degli Artisti di Luigi Magni, romano de Roma, abituato ad appaiare i sarcastici e disincantati motteggi vernacolari all’incanto di divenire palmo a palmo aedo della città natia, resta indelebile. I cinefili autoctoni non scorderanno mai la sequenza di Nell’anno del signore col passaggio di consegne dell’irriverente ed estroso Pasquino. La maschera incredula, luminosa e buffa di Pippo Franco nei panni dell’apprendista denominato Bella chioma (nella foto), magistralmente diretto da Magni, sembra uscita dalla macchina del tempo della commedia dell’arte. A seguire la penna del maestro correre sul foglio «come una lepre». Per svegliare la coscienza del popolo, per inchiodare gli aguzzini alle loro infamie, per rammentare al discepolo che «solo sul sangue viaggia la barca della rivoluzione». 
Era il 1969 e Pippo Franco intendeva lasciare un segno indelebile anche sul grande schermo. Mettendosi a disposizione degli influenti registi eletti legittimamente ad Autori con la “a” maiuscola. Per metterci a ogni buon conto pure del suo. E così avvenne. Billy Wilder nella commedia romantica Che cosa è successo tra mio padre e tua madre?, anziché servirsene alla stregua d’una semplice pedina per lo scacchiere complessivo, si fidò dell’istinto del caratterista romano. Desideroso di acquisire la qualifica del protagonista a tutto tondo. Per niente intimidito di recitare accanto a un mostro sacro come Jack Lemmon, Pippo Franco ripagò al meglio la fiducia accordatagli dall’autore austriaco. Naturalizzato yankee. L’interpretazione dell’impresario funebre Matarazzo (nella foto) con la giacca piena di tutto l’occorrente sembrò invertire i ruoli. Poteva apparire paradossale che fosse Pippo Franco a imbeccare Billy Wilder sui faceti e ingegnosi risvolti del personaggio. Ma non erano in ballo inquadrature lusinghiere. Il naso importante – accostabile per alcuni versi a quello del coraggioso spadaccino Cyrano de Bergerac, paragonato dall’arguto uomo di lettere Edmond Rostand a «un’erta, un capo, un’insegna per una profumeria, un degno trespolo per i volatili canterini, un promontorio da cui partirono mille e più navi» – non glie lo avrebbe comunque rese affatto facili. L’ironia, l’autoironia, l’inventiva costante, la prontezza parodistica cementarono l’intrinseco status di co-autorialità. 
Ed è per questa ragione che il nostro affezionatissimo fa tranquillamente spallucce davanti ai borbottoni che lo considerano più che altro un comico di grana grossa. Invece di riconoscergli le composite finezze intellettuali. In Quel gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda Pippo Franco (nella foto) ha dato una notevole mano in cabina di regia al concittadino Mariano Laurenti per trasformare l’innocua commedia farsesca in un inno contro i tutori della salute morale che mandavano al rogo i film ritenuti sconci. A discapito del diritto di esprimersi lontano dalle iniziative repressive adattando le stigmate dell’erotismo alle punzecchiature, all’assonante calembour, alle numerose risorse della commedia dell’arte. Per razionalizzare l’assurdo. Indagare nei costumi in costante subbuglio. Alimentare il rivolo della risata. Stemperare nell’arlecchinata vivace e nella burla sagace le aride controversie.
Travestendosi da donna, mantenendo di soppiatto l’istinto da casanova impenitente, in Zucchero, miele e peperoncino, sulla scorta della performance di Jack Lemmon nel cult A qualcuno piace caldo, spianò la strada in campo internazionale nientepopodimeno che a Dustin Hoffman. Che, va rimarcato, con Tootsie (nella foto) alzò il tiro. Impartendo un’autentica lezione di recitazione con la notevole ed epidermica psicotecnica immedesimativa perfezionata in veste di allievo dell’insigne Actors Studio. 
Ma a Pippo Franco a quel punto premeva assai più dare ulteriore lustro alla compagnia di varietà Il Bagaglino (nella foto) fondata da Pier Francesco Pingitore. In qualità di capobanda dell’affiatata ciurma, con Oreste Lionello e Leo Gullotta sugli scudi, il largo sorriso dell’ormai ex Bella chioma non subì mai flessioni d’alcun genere. La miniera di aneddoti, il pungolo professionale fornito dalla vena canzonatoria, le debite modalità linguistiche, le domande a trabocchetto, il gioco degli equivoci, la proverbiale leggerezza, dispiegata a dispetto delle polemiche di rito e delle questioni di lana caprina, misero in mutande l’improntitudine malcelata della classe politica. Il ricordo delle nozioni apprese al liceo artistico a via Ripetta, del poor theatre, dei monologhi pronunciati in gioventù negli allestimenti ridotti, col pubblico, giudice supremo, seduto a due passi, ne ha incoraggiato al massimo i guizzi, i veicoli privilegiati, le mire sarcastiche. Accompagnate da pause accorte, occhi sporgenti, pertinenti reazioni mimiche alle incerte risposte dei presunti dotti. 
Redigendo il libro La morte non esiste: La mia vita oltre i confini della vita, Pippo Franco ha infine compiuto un amarcord all’insegna della predilezione per lo spirito. Che manda a carte quarantotto la materia, le opportunistiche revisioni d’ideali, i politici convinti di tenere in pugno le redini del partito, conducendo in realtà un’impari lotta coi congiuntivi, il fumo negli occhi buttato da chiunque confonda il Colosseo con il Cupolone e dai frivoli alfieri del multitasking, preoccupati solo ed esclusivamente dell’immagine da dare di sé al mondo esterno. Per Pippo Franco non c’è gara: l’interiorità, unita alla bellezza dell’anima, batte l’esteriorità dieci a zero. Un cappottone! Inutile vestire la pelle del leone. Specie da tastiera. L’esempio fornito dal conduttore del Bagaglino consiste nell’evitare come la peste i processi alle intenzioni, nel non prendere mai alla larga i vincoli di sangue e di suolo, nel non fare primiera con tre carte, né tirare giù i santi dal cielo. Facendoci bensì affidamento per salvaguardare l’allegrezza. E dare scacco matto a qualsivoglia scontentezza.
**** **** **** **** ****
1). D / Che aria si respirava sul set dei film di Luigi Magni (nella foto)?
R / C’era un’atmosfera di grande complicità. Gigi veniva a vedere i miei spettacoli di cabaret, all’epoca degli esordi, con poche persone in sala: teneva in notevole considerazione questi tipi di spettacolo. Anche prima che incontrassero il favore del pubblico. Mi ha diretto in quattro film. Ne abbiamo pure scritto un quinto. Ma poi non se n’è fatto più nulla. Lo ricordo con enorme affetto. La nostra collaborazione costituisce una delle più importanti esperienze della mia vita. Sotto l’aspetto professionale e umano. 
2). D / Balzava agli occhi, infatti, che, oltre a un’enciclopedica conoscenza della storia e un personalissimo sguardo d’autore, il compianto Luigi Magni avesse una profonda umanità. La vostra romanità, seppur assai diversa, è stata la ciliegina sulla torta?
R / È divenuta senz’altro un valore aggiunto. Gigi aveva parecchie frecce al suo arco: il gusto della battuta, tipicamente romana, la schiettezza, la generosità, l’estro dietro la macchina da presa. Ma soprattutto la virtù di osservare e sviscerare la storia attraverso un’ottica molto particolare. Sapeva andare in profondità. Grazie agli stimoli emotivi che era solito ricavare dalle nozioni intellettuali. Ripristinando alcuni valori quasi sconosciuti. Senza travisarli. Scoprendoli piuttosto a beneficio del pubblico.
3). D / Permettendo così agli spettatori ai quali avevano ucciso la maestra di colmare le loro lacune e appassionarsi alla storia. L’inquadratura finale in Nell’anno del signore della lapide commemorativa riguardante la decapitazione di Targhini e Montanari (nella foto), situata sul fianco della Caserma dei carabinieri, dinanzi alla chiesa di Santa Maria del Popolo, lo testimonia. La geografia emozionale per Magni significava scoprire la storia custodita in targhe a cui pochi facevano caso?
R / Assolutamente sì. Era un uomo e un artista che amava moltissimo la sua città, ne conosceva ogni angolo. Abitava a via del Babbuino. Quella targa l’aveva sotto gli occhi tutti i giorni. E lui a queste cose prestava attenzione. A differenza di altri, più superficiali, concordo con lei, che non ci fanno caso. È incredibile invece come la tautologia ci si metta di mezzo quando si tratta d’individui sensibili ed eruditi della levatura di Gigi. Ed è lì che con ogni probabilità è scattata la molla dell’ispirazione all’origine di Nell’anno del signore. La geografia emozionale, come l’ha definita, gli permetteva di creare nei grandi luoghi dell’anima, come Piazza del Popolo, degli insoliti teatri a cielo aperto in cui si respirano ancor oggi echi di storie avvincenti ed emblematiche. Partendo da targhette in apparenza ignote. Come appunto la lapide in questione. D’altronde, ribadisco, la sua sete di conoscenza e il desiderio di comunicare andavano a braccetto con lo stimolo delle emozioni. 
4). D / Ed è una conclusione memorabile, quella realizzata in Nell’anno del signore, che coglie di sorpresa gli spettatori conciliando per una volta cuore e cervello. Verrebbe da pensare che l’autore cinematografico condividesse il punto di vista ateo dei due condannati. Talmente decisi nel sottrarsi ai conforti religiosi da affermare: «Non abbiamo conto da rendere a nessuno: il nostro Dio sta in fondo alla nostra coscienza». Lei, da amico e fervente cattolico, crede, per così dire, che il cervello di Magni preferisse l’ateismo identitario mentre il cuore fosse alla ricerca della Fede?
R / Gigi era critico nei confronti delle istituzioni religiose e del potere temporale e secolare della Chiesa sotto il profilo storico e culturale. Perché, già dall’epoca dei Borgia, hai voglia a discutere dei conduttori della Fede. Le lotte intestine, le lotte sociali, le lotti individuali, in difesa delle proprie credenze, a Roma sono sempre state esplosive. Chi racconta queste storie però in fondo dà valore all’elemento della Fede in Dio. Che poi non si sia fatto mancare la puntura di spillo ai papalini, beh quello è un altro paio di maniche. Gigi non lo manifestava apertamente. Ma, seppure preceduta dalle sue idee critiche, la ricerca della fede, della replica umana alla parola di Dio, dell’egemonia dello spirito sulla materia era molto presente nei suoi film.
5). R / Lo dimostra anche il commiato funebre dell’ufficiale papalino, il nobile Don Prospero di Sant’Agata, per la morte del figlio Urbano, seguace della causa unitaria, in Arrivano i bersaglieri (nella foto) dove lei impersona lo scaltro e inquieto Padre Paolo. L’incipit di Nell’anno del signore richiama invece alla mente quello di Un uomo per tutte le stagioni di Fred Zinneman. Incentrato sul probo umanista cattolico Thomas Moore. Beatificato da Papa Leone XIII e canonizzato da Pio XI. Cosa pesa di più sul piatto della bilancia la salda coerenza o il saggio criterio?
R / In primo luogo se Gigi ha scelto di raccontare il dolore del padre per un figlio dalle idee diverse dalle sue, e di conseguenza qualcosa al di sopra, che va oltre, come la Fede in Dio, è perché, sotto sotto, non poteva non considerare Roma Caput Mondi anche sotto l’aspetto della Fede in Dio. Come luogo consacrato allo spazio sacro del cielo. Per quanto riguarda Thomas Moore, che scelse di non rinnegare le proprie convinzioni religiose accettando la pena capitale, è difficile dare una risposta. Ciascun essere umano reagisce in modo differente di fronte a una realtà estrema come questa. Ci sono persone che cercano di salvare la vita, che è sacra, e altre, viceversa, che sono disposte a rinunciarvi pur di rimanere fedeli alle proprie idee e alle proprie azioni. Quest’atto di fede costituisce un altro tipo di sacralità. Thomas Moore, ma anche Targhini e Montanari scelsero questo secondo tipo di sacralità. Cornacchia alias Pasquino di Nell’anno del signore preferì serbare l’istinto di conservazione e il primo tipo di sacralità.

6). D / A ciascuno il suo: ogni capoccia è un tribunale?
R / Appunto.
7). D / Ne Il nome della rosa Umberto Eco sostiene che la santità, a dispetto di chi considera il riso un vento diabolico, si è servita delle burle per cogliere in flagrante i nemici della Fede. Il valore terapeutico dell’umorismo va dunque di pari passo con l’opera di salvezza rappresentato dalla fede nella parola di Dio?
R / Io preferisco metterla in questo modo: l’ironia significa allegrezza. Sigmund Freud (nella foto) nel libro Il motto di spirito che tratta della relazione con l’inconscio si è chiesto perché l’Uomo vuole ridere. E arriva alla conclusione che il desiderio di ridere dell’Uomo coincide con quello di tornare bambini. Quando non avevamo bisogno dell’umorismo per essere felici. Quindi l’ironia, torno a ripetere, chiamiamola allegrezza. Il Cantico delle Creature di San Francesco – con Fratello Sole, Sorella Luna – indica la strada da seguire. All’insegna dell’allegrezza. E, pertanto, dell’ironia. 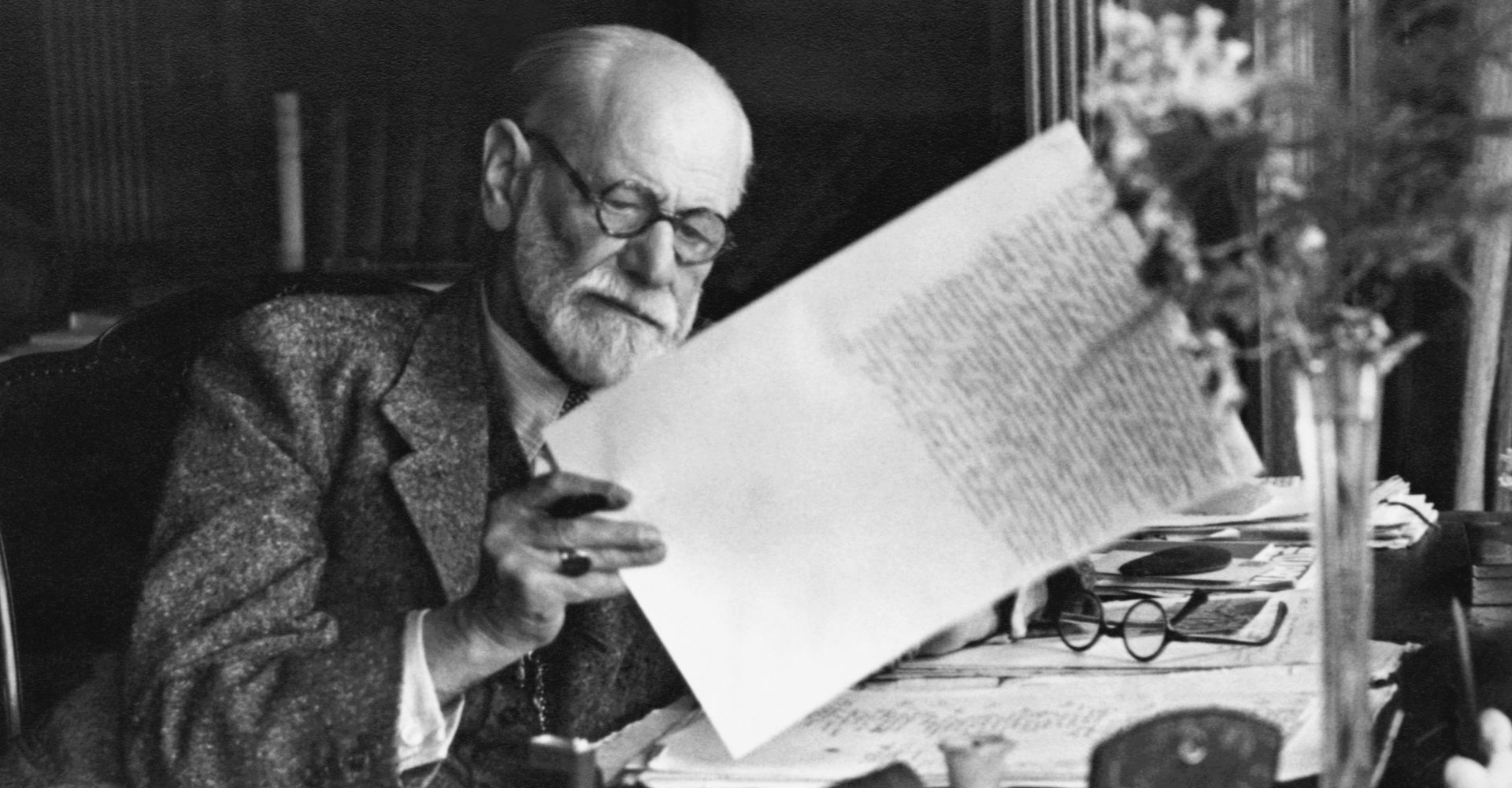
8). D / Esiste ironia senza autoironia?
R / Non può esistere ironia senza autoironia. L’ironia tira fuori in sintesi la verità. Rendendola grottesca. Oggetto di perenne divertimento. Motivo d’allegrezza. Basti pensare a quante caricature e a quante vignette hanno contribuito a scoperchiare realtà scomode nell’arco della nostra storia recente. Bisogna però prima conoscere se stessi, riconoscere i rispettivi punti di forza e le debolezze, saperci scherzare. Prendere perciò la vita con leggerezza. Anziché prendersi troppo sul serio. Senza l’arte di saper ridere di se stessi non ci può essere la felicità.
9). D / D’ironia e di autoironia Giulio Andreotti (nella foto con Pippo Franco e Oreste Lionello nei panni dell’imitatore dell’ex senatore), al di là dei processi ora di santificazione, prima di demonizzazione nei suoi riguardi, n’era provvisto a iosa. Vi siete capiti al volo?
R / Andreotti era una mosca bianca. La politica non è mai ironica e autoironica. Se ci pensiamo bene, un’altra eccezione che conferma la regola è forse rinvenibile nell’ex primo ministro britannico Winston Churchill. Ha fatto scuola in qualche modo. Una persona come Andreotti al giorno d’oggi non è tuttavia nemmeno immaginabile. I politici sono convinti che una persona ironica e autoironica, capace di rivolgere l’umorismo verso se stessa, perda di credibilità. Di prestigio. Hanno paura di essere messi in mezzo dai comici di mestiere. Nasce tutto dall’insicurezza. Andreotti al contrario sapeva il fatto suo. Era forte della sicurezza in sé stesso. Ricordo che quando venne al Bagaglino non volle che gli anticipassi le domande. Gli altri politici per sembrare autoironici e dare l’impressione di rispondere con prontezza preferiscono saperle prima. Lui, no. Andava a braccio. Senza alcun timore. 
10). D / Giovannino Guareschi sulle pagine del settimanale umoristico Candido, con le rubriche Visto da destra e Visto da sinistra, menava fendenti micidiali ed esilaranti ai padroni del vapore troppo pieni di sé. Anche lei con il Bagaglino, come si suol dire a Roma, non c’è mica andato liscio. Perché invece gli umoristi odierni hanno le polveri bagnate? È colpa loro oppure dei tempi?
R / Direi che la colpa è dei tempi. La genia di coloro che restano legati alla propria storia, alla propria cultura, e anche, di conseguenza, all’ironia, non morirà mai. Ed da lì che parte la possibilità di comprensione delle cose più difficili da capire di primo acchito. Ma parliamo di geni. Di persone superiori. Come Andreotti e lo stesso Guareschi. Oggi pure si possono comunicare pensieri degni di rilievo. Però con un linguaggio ben diverso. È cambiata la soglia di attenzione. Si è abbassata, involuta. Il cicaleggio passa, magari. I concetti corroborati dall’ironia e dall’autoironia, molto meno. Gli scambi via chat, attraverso i social media, ubbidiscono a logiche comunicative diverse. Che sfociano, se vogliamo, nella poesia ermetica, nei suoi contenuti più rilevanti, ma anche nel ridicolo involontario. Salvatore Quasimodo (nella foto) con i versi «Ognuno è solo sul cuor della terra ed è subito sera» andava realmente in profondità, nei meandri dell’animo umano, indagando temi come il distacco, i vincoli di suolo, l’ordine naturale delle cose e la caducità della vita con una sintesi fulminante. La sintesi sui social è sì ermetica. Però resta in superficie. 
11). D / La sintesi dei social è ermetica perché è un guazzabuglio di parole vuote: non si capisce un’acca. Cosa ispirava, prima del turbine della mitomania e del tracollo dell’autoironia, le parole piene?
R / Oggi imperano gli influencers e quelli che vengono influenzati nel modo di comportarsi. Magari costituiscono la minoranza; tuttavia degli influencers che hanno qualcosa d’interessante da comunicare ci stanno eccome. Il nodo della questione, in ogni caso, è relegato a un’altra faccenda. Bisogna fare i conti con la realtà attuale. Un tempo le nazioni erano poetiche. L’Italia in modo particolare. Il senso della poesia si è andato perdendo. I contenuti latitano. I contenuti di prima erano ravvisabili nel periodo della fame, degli stenti, del loro strenuo superamento. Con la necessaria forza di volontà. Con l’ironia. E l’autoironia. Adesso si cercano cose prive di contenuto. Senza nesso con la realtà. I contenuti di Guareschi, che ha giustamente citato, oggi sono utopici.
12). D / Lei è entrato nell’immaginario collettivo nazionale pure per una canzone divenuta presto un tormentone: Mi scappa la pipì papà! (nella foto). I bambini sono effettivamente i veri maestri?
R / Ho un’amica che insegna il tip tap. E guida i bambini. Certo, sono selezionati. Anche tutti i bambini coinvolti nella canzone erano adeguatamente preparati. E si divertivano tantissimo. Era un gioco al quale partecipavamo all’unisono. Ed eravamo spesso noi adulti, oltre che a insegnare, ad apprendere qualcosa di basilare, ricordandoci, grazie al loro ingenuo e trascinante modo di fare, le tenere e rassicuranti favole alle quali un tempo credevamo con tutto noi stessi. 
13). D / Un bel Do ut des. Scevro dal calcolo. Adesso che ha accettato la proposta del candidato sindaco Enrico Michetti (nella foto) entrando a far parte della sua lista, all’assessorato alla cultura, se dovesse andare in porto, offrirà la sua esperienza per la gestione, il servizio in tal senso o darà solo dei suggerimenti d’ordine pratico?
R / Se dovesse andare in porto, preferirei fare per l’appunto il consulente. Ho accettato perché mi sono sentito in dovere di farlo. Quando parliamo di quello che possiamo fare per Roma, anche nell’ambito delle cose che non sono mai state fatte, non rimango certo indifferente. La politica di per sé non m’interessa. Roma, invece, l’amo. Ho già avuto modo di dire che è passata da Caput Mundi a Kaputt. Un tempo camminando per Lungotevere si poteva ammirare uno scenario unico: geografia emozionale allo stato puro. Ora è tutto un accampamento. Questo degrado rappresenta il simbolo di quello che non è stato fatto per Roma. Lì invece è custodita l’intera sua storia. A parte qualche rassegna e qualche locale lungo il fiume, il rilancio del Tevere è fermo ai nastri di partenza. Mi piacerebbero che rivivessero sul serio certe atmosfere magiche nell’Isola Tiberina, allo Scalo de Pinedo, a Lungotevere dei Vallati, a Ponte Sisto, a Lungotevere in Augusta, a Lungotevere de’ Cenci. 
14). D / Atmosfere che non avevano nulla da invidiare ai giri sulla Senna di notte. Anzi. Altro che movide! Difendere i valori ereditati dalla tradizione è il modo ideale per ritornare da Kaputt a Caput Mundi?
R / È l’unica strada percorribile. Soltanto l’arte può attraversare Roma. Per arte intendo l’architettura dei monumenti, la storia, tutto quello che è passato per la Città Eterna. I soffi vitali degli avvenimenti passati sono incastonati nei suoi luoghi: stanno là. Farli rivivere, coinvolgendo chi di dovere in maniera pratica, attiene al senso d’appartenenza dal mio punto di vista. Da piccolo vivevo a Corso Rinascimento 77. Davanti al Senato. Passavo le giornate in finestra a guardare le strade, i palazzi, la chiesa di Sant’Andrea della Valle che offre riparo al pittore e satiro romano antipapalino Mario Cavaradossi quando scappa da Castel Sant’Angelo ne La Tosca di Giacomo Puccini. Ricordo alla perfezione anche le parate militari, la banda musicale, il tamburo maggiore che manteneva lo schieramento e dirigeva il gruppo indicando con una mazza al complesso degli strumenti a fiato gli attacchi, le note, la fanfara. Vedevo i cavalli da tiro pesante che consegnavano il ghiaccio all’osteria sotto casa. Fa parte di una storia intima che non possiamo né vogliamo dimenticare. In sostanza non si può lasciare Roma senza arte. Tanto più se è strettamente legata alla profonda memoria storica dei suoi abitanti. È l’arte, intesa nella sua accezione più completa, come anche l’arte dello spettacolo, dei festival, degli idonei spazi di confronto, che può e deve coinvolgere tutti. Da chi ci vive ai turisti. Decisi ad apprendere la storia. Anche degli avvenimenti in apparenza minori. Come ci ha insegnato Gigi Magni.
MASSIMILIANO SERRIELLO



















