
PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Scritto da Enea Jr. Franza il . Pubblicato in Economia, Finanza e Politica.
nella foto di apertura, un vertice di Mario Draghi con i Ministri del suo Governo
ALCUNE “OSSERVAZIONI SCOMODE” SUL PNRR
E IL PARAMETRO DELLA PRODUTTIVITÀ
a cura di Enea Franza*
Si discute ancora molto se la bassa produttività del lavoro, caratteristica da diversi anni del nostro sistema produttivo, sia legata alla dimensione delle aziende italiane, ovvero, trovi ragione in altre variabili del mercato, come l’alto costo del lavoro, ovvero, il basso valore del prodotto.
In effetti, il parametro della produttività (data dal rapporto fra valore aggiunto e occupati totali) misura il rendimento medio dell’input di lavoro in termini di produzione. Peraltro, da questo parametro dipende anche il c.d. “costo del lavoro” (o CLUP), dato dal rapporto tra redditi medi da lavoro dipendente e produttività media del lavoro.
Prima di proseguire occorre tuttavia osservare che la produttività del lavoro non è stata sempre bassa. Anzi c’è stato un periodo in cui l’Italia vantava un primato che faceva dei nostri lavoratori i “giapponesi” d’Europa. Peraltro, la dinamica della produttività italiana è stata per lungo tempo in linea con quella tedesca, in particolare nei decenni scorsi, e si arresta a partire dalla seconda metà degli anni 90. Ora credere che le imprese italiane siano diventate di colpo tutte microscopiche ed improduttive a partire da quegli anni, lascia davvero increduli e pone in forte dubbio la validità di una tesi che imputi la perdita di produttività prevalentemente al nanismo delle nostre imprese.
Ma allora qual è a questione? Bene, notiamo, prima di addentrarci sul tema, che un aumento della produttività del lavoro, comporta una riduzione del costo del lavoro (che diminuisce a parità di reddito medio) e che quindi, in linea di principio e considerando un mercato oligopolistico, se diminuisce il CLUP diminuiscono anche i prezzi alla produzione. La riduzione dei prezzi alla produzione, dunque, si ripercuote su quella dei prezzi nel lungo periodo. Ne segue, adesso forse con più evidenza, la centralità della discussione. Una maggiore produttività calmiera i prezzi e, in definitiva, rende l’impresa più competitiva.
Per aumentare la produttività non sono poche le ricette suggerite dagli economisti. In effetti, il progresso tecnico e la diffusione di  nuova tecnologia è uno degli strumenti (anche intuitivamente) più efficaci e, in tal senso, la rivoluzione digitale è capace di portare benefici notevoli all’impresa che l’applicasse correttamente; peraltro verso, anche l’aumento della dimensione aziendale permette, senz’altro, di beneficiare di economie di scala e, questo, considerata la presenza nel nostro paese di tante piccole imprese spesso marginali, è un importante asso nella manica per chi sostiene (anche a ragione) che un forte impulso alla crescita della produttività possa venire da una politica di favore verso accorpamenti d’imprese. Peraltro, le politiche nazionali che favoriscano l’implementazione nella conoscenza e nell’uso efficiente dei fattori produttivi, ovvero, il recupero aziendale di spazi di inefficienza, ovvero che incoraggino innovazioni nel processo produttivo, miglioramenti nella organizzazione del lavoro e delle tecniche manageriali, o migliorino il livello di istruzione e formazione della forza lavoro, ulteriore strumento di recupero di produttività, sono favorite senz’altro in realtà più grandi rispetto ad imprese con dimensione familiare. Dunque, il mantra “innovazione – ricerca e sviluppo” ha ben ragione di colpire una parte della verità.
nuova tecnologia è uno degli strumenti (anche intuitivamente) più efficaci e, in tal senso, la rivoluzione digitale è capace di portare benefici notevoli all’impresa che l’applicasse correttamente; peraltro verso, anche l’aumento della dimensione aziendale permette, senz’altro, di beneficiare di economie di scala e, questo, considerata la presenza nel nostro paese di tante piccole imprese spesso marginali, è un importante asso nella manica per chi sostiene (anche a ragione) che un forte impulso alla crescita della produttività possa venire da una politica di favore verso accorpamenti d’imprese. Peraltro, le politiche nazionali che favoriscano l’implementazione nella conoscenza e nell’uso efficiente dei fattori produttivi, ovvero, il recupero aziendale di spazi di inefficienza, ovvero che incoraggino innovazioni nel processo produttivo, miglioramenti nella organizzazione del lavoro e delle tecniche manageriali, o migliorino il livello di istruzione e formazione della forza lavoro, ulteriore strumento di recupero di produttività, sono favorite senz’altro in realtà più grandi rispetto ad imprese con dimensione familiare. Dunque, il mantra “innovazione – ricerca e sviluppo” ha ben ragione di colpire una parte della verità.
Già, però, a ben vedere, solo una parte della verità. Il passaggio che manca, infatti, è che guardando solo questo lato della questione (da economista direi il lato dell’offerta) si dimentica che ogni imprenditore ha un principale grosso problema che, in poche parole, potremmo riassumere nel “vendere ciò che produce”; se, per qualche motivo, i suoi beni non riescono ad avere mercato, egli non ha nessuno stimolo a produrre.
E veniamo, quindi, al nocciolo della questione. Proprio quando l’imprenditore è schiacciato da un quadro macroeconomico che gli chiude i mercati di sbocco, egli non potrà vendere ciò che produce o lo venderà a prezzi stracciati. Ora il basso plusvalore delle vendite, impattando sul numeratore del nostro rapporto, avrà come conseguenza una bassa produttività e, quindi, un alto costo del lavoro. Come si vede, si può incidere sul denominatore del rapporto quanto si vuole (con le politiche dell’offerta), ma se la merce non si vende, si tratterà di interventi con effetti marginali e che, soprattutto, non coglieranno l’obiettivo di generare vera crescita.
Ecco, dal mio punto di vista, il problema italiano: quando il nostro paese si è trovato ad agganciare un cambio (parzialmente con lo 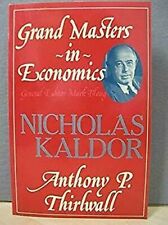 SME e, definitivamente, con l’Euro) ha compromesso le proprie esportazioni e, quindi (solo dopo) la produttività è andata giù. In altre parole, tutte le volte che abbiamo adottato un cambio sopravvalutato (il tasso di cambio in effetti non è che un prezzo) abbiamo compromesso i mercati di sbocco, quindi le esportazioni e, dunque, la produttività.
SME e, definitivamente, con l’Euro) ha compromesso le proprie esportazioni e, quindi (solo dopo) la produttività è andata giù. In altre parole, tutte le volte che abbiamo adottato un cambio sopravvalutato (il tasso di cambio in effetti non è che un prezzo) abbiamo compromesso i mercati di sbocco, quindi le esportazioni e, dunque, la produttività.
Peraltro, la mia osservazione non è affatto nuova. Lo scriveva già Adam Smith che la produttività è endogena e dipende dall’ampiezza del mercato, ed anche il modello Kaldor-Thirlwall, il cui enunciato semplificato indica che la crescita di un paese è direttamente proporzionale a quella delle sue esportazioni, si basa su tale assunzione. Ma per restare in Italia, mi piace ricordare la parabola  dell’albero da frutta di Luigi Einaudi. In tale comparazione, l’ampliamento del mercato, rendendo conveniente la divisione del lavoro, dà luogo allo sviluppo della specializzazione e all’adozione di nuove tecnologie da parte di singole imprese. Ciascuna impresa può imitare le altre, se trova che ciò riduce i costi e migliora la qualità dei prodotti. L’ampliamento del mercato comporta anche l’entrata in campo di un maggior numero d’imprese, e ciò accresce la concorrenza. Tramite questa, le riduzioni dei costi si trasferiscono ai consumatori: “La concorrenza, che con un mercato ampio è assai più arduo sopprimere o limitare che su un mercato ristretto, agisce e costringe i produttori a ridurre i prezzi al livello dei costi marginali”. Nella teorica einaudiana dei mercati aperti, dunque, la concorrenza tendenzialmente non porta a un equilibrio stazionario, ma genera un processo dinamico di riduzione dei costi, tramite le innovazioni di processo e di prodotto, che sono incessantemente stimolate dall’esigenza di sostenere il livello dei profitti, continuamente erosi dai competitori che imitano gli innovatori. Ma resta inteso che tutto ciò è possibile in un quadro di mercati che si ampliano.
dell’albero da frutta di Luigi Einaudi. In tale comparazione, l’ampliamento del mercato, rendendo conveniente la divisione del lavoro, dà luogo allo sviluppo della specializzazione e all’adozione di nuove tecnologie da parte di singole imprese. Ciascuna impresa può imitare le altre, se trova che ciò riduce i costi e migliora la qualità dei prodotti. L’ampliamento del mercato comporta anche l’entrata in campo di un maggior numero d’imprese, e ciò accresce la concorrenza. Tramite questa, le riduzioni dei costi si trasferiscono ai consumatori: “La concorrenza, che con un mercato ampio è assai più arduo sopprimere o limitare che su un mercato ristretto, agisce e costringe i produttori a ridurre i prezzi al livello dei costi marginali”. Nella teorica einaudiana dei mercati aperti, dunque, la concorrenza tendenzialmente non porta a un equilibrio stazionario, ma genera un processo dinamico di riduzione dei costi, tramite le innovazioni di processo e di prodotto, che sono incessantemente stimolate dall’esigenza di sostenere il livello dei profitti, continuamente erosi dai competitori che imitano gli innovatori. Ma resta inteso che tutto ciò è possibile in un quadro di mercati che si ampliano.
Per altro verso oramai sembra acquisito che la competitività tedesca sia dovuta, in effetti, ad un listino prezzi svalutato dall’euro ed a politiche del lavoro spesso scorrette e scoordinate rispetto agli altri partner europei; quindi un aumento di produttività (quello dei teutonici) realizzato in definitiva col taglio dei salari reali (come, peraltro, gli stessi sindacati tedeschi rivendicano da tempo) e non a guadagni di produttività e, il cui tasso di crescita, ha mostrato un calo almeno dal 2003 e, oggi, è tutto sommato stagnante (a dimostrazione che la produttività ha bisogno di mercati di sbocco delle merci prodotte)
Da dove viene quindi l’idea che se siamo poco produttivi è colpa dei mancati investimenti produttivi? (e scusate il bisticcio di parole).
Certamente contribuisce a questo la visione “neoclassica” secondo cui è l’offerta a creare la domanda; il classico ritornello che tenta di spiegare la crescita (e quindi anche la dinamica della produttività) solo dal lato della produzione. E, per tornare all’attualità della cronaca economica, anche il nuovo Piano Nazionale Resilienza e Resistenza (PNRR) con gli incentivi ad investimenti produttivi, rivoluzione digitale ecc. sembra disegnato su questa idea.
Ma, peraltro, questa politica economica porta in seno una contraddizione; se, in definitiva, si tengono bassi i salari monetari (ed i salari monetari sono bassi, per una dinamica inflattiva molto bassa e un’alta disoccupazione) come si potrà pretendere che l’impresa scelga di investire, quando, è ovvio, che preferirà utilizzare più lavoro (che costa meno) e meno capitale, ed investirà poco o niente in ricerca e sviluppo.
Ecco, perché a nostro modo di vedere i tanti soldi, pur se affluiranno al nostro Paese, non daranno i benefici auspicati.
Le ragioni, come cennato sono essenzialmente due. La prima e che gli interventi messi in campo non incidono (o meglio incidono solo parzialmente e, soprattutto, non nella misura necessaria) sulla domanda interna, né tanto meno su quella esterna favorendo le esportazioni. Non essendoci lo stimolo a produrre, infatti, non si capisce perché le imprese dovrebbero fare (convintamente) nuovi investimenti se non “profittare” di denari messi a disposizione dallo Stato, con innovazioni predatorie; in secondo i previsti incentivi alle assunzioni, mirano a tenere bassi i salari e ciò crea un incoraggiamento ad utilizzare manodopera a basso costo, oltre a disincentivare, nuovamente, l’innovazione e gli investimenti.
A ciò, non mancherò mai di sottolinearlo, va aggiunto che ad impattare negativamente sulla produttività c’è la dinamica dei bassi tassi di interesse, che ha prodotto distorsioni allocative nel mercato finanziario. Basterebbe anche qui rileggere Von Hayek: il mantenimento artificioso di tassi di interesse troppo bassi per molto tempo crea incentivi ad intraprendere investimenti eccessivi (e poco produttivi), che poi si risolvono in bolle speculative destinate, al loro scoppio, a lasciare l’economia in condizioni di depressione.

*ENEA FRANZA
Direttore Dipartimento Scienze Politiche
di UniPace-O.N.U., Delegazione di Roma
Economista, Editorialista e Saggista
– Condirettore Consob



















